Omar Hassan Ahmad al-Bashir e il Sudan moderno
Omar Hassan Ahmad al-Bashir ha ricoperto il ruolo di capo di Stato del Sudan dal 1989 al 2019, quando è stato deposto con un golpe militare. Al-Bashirm salito anch’esso al potere tramite un colpo di stato militare nel 1989 a scapito del primo ministro Sadiq al-Mahdi, dopo che questi aveva avviato negoziati con i ribelli del Sud.
Fortemente ostile a qualsiasi negoziato per riconoscere l’indipendenza dell’odierno Sud Sudan, nel 1992 al-Bashir fonda il Partito del Congresso Nazionale, con lo scopo di non lasciare il potere e lavorare su una transizione politica che lo riconfermasse, come avvenuto fino al 2019. La storia di al-Bashir è caratterizzata da un accentramento costante del potere e da un’ostilità per le posizioni di compromesso che hanno causato la morte di milioni di persone, in particolare nelle regioni del Darfur e l’odierno Sud Sudan.
Paese, quest’ultimo, divenuto ‘’famoso’’ per le numerose missioni di supporto umanitario della comunità internazionale, necessarie per cercare di rispondere alle necessita basiche della popolazione. La tragedia che investì questi territori causò la fuga di milioni di persone che trovarono rifugio nelle vicine Etiopia, Kenya e Ciad ma che riuscirono a sopravvivere solo grazie ad un enorme sforzo della comunità internazionale che si fece carico di tutti i nuovi rifugiati nei paesi di destinazione.
Il Darfur
Dal 2003, il Darfur è stato teatro di un conflitto che ha visto contrapposta la maggioranza della popolazione. Divisa tra tribù sedentarie, e la minoranza nomade, proveniente dalla penisola araba, maggioritaria nel resto del paese e che gode dell’appoggio del governo centrale, accusato a sua volata da entrambe le fazioni di tollerare le feroci scorribande dei janjāwīd (i “demoni a cavallo”). Dal 1985, e ancor di più dal 2002, il governo centrale ha strumentalizzato queste controversie, applicando una strategia per cercare di dividere le etnie e renderle il più debole possibile. Durante la presidenza di Al Bashir, si registrano diversi scontri tra le milizie janjāwīd e altri gruppi ribelli come l’Esercito di liberazione del Sudan (SLA) e il Movimento per la giustizia e l’uguaglianza (JEM) che rappresentava la regione del Darfur.
Altri aspetti di carattere climatico legati a una drammatica siccità con conseguente desertificazione del suolo e carestia hanno presentato il Darfur all’opinione pubblica internazionale, come una delle più urge ti e complesse situazioni di intervento umanitario a cui rispondere.
La guerra per il Sud Sudan
Se per il Darfur si parla di un problema di etnie, per il Sud Sudan in gioco esiste un aspetto economico ancora più importante legato al petrolio. Partendo dalle posizioni estreme di Bashir sulla negazione di uno stato sudsudanese, la regione è stata teatro di due guerre civili, combattute tra l’esericto governativo e l’Esercito di Liberazione del Popolo del Sudan (ELPS).
Durante il conflitto, come misura estrema e disumana per indebolire l’ELPS, il governo centrale sudanese si è disinteressato completamente della situazione umanitaria dei sud sudanesi, ignorando la mancanza di importanti infrastrutture civili, incoraggiando la fuga di molti profughi e la devastazione di aree produttive con azioni militari.
Si stima, oltre alle vittime di guerra, un totale di 2.5 milioni di persone decedute per malnutrizione, e 5 milioni di rifugiati presenti in altri Paesi.
Nel gennaio 2011 i cittadini del Sudan del Sud decidono tramite un referendum se separarsi o meno dal resto del Sudan e dichiararne l’indipendenza. L’affluenza fu elevatissima, circa il 96% degli aventi diritto e a fine mese i risultati mostrarono come la popolazione, con il 98,81% di voti favorevoli fosse nettamente a favore dell’indipendenza.
A seguito del risultato, il 9 luglio 2011 il Sudan del Sud, malgrado non vengano risolte alcune controversie con il Nord, si dichiara Stato sovrano e indipendente. Il principale punto di discordia è la ripartizione dei proventi del petrolio, i cui giacimenti si trovano all’80% nel Sudan del Sud e rappresentare un incredibile potenziale economico in un’area fra le più povere al mondo, mentre la maggior parte degli impianti di raffinazione si trova al Nord.
Abyei, regione contesa in questa disputa, deciderà con un referendum a quel ei due stati vorrà appartenere. Oltre che da diatribe territoriali, l’instabilità nel neonato Sud Sudan proviene anche da faide interne alla classe politica dirigente. Con un tentativo di colpo di Stato nel dicembre del 2013 le forze leali al presidente Salva Kiir, di etnia Dinka, si sono scontrate con quelle fedeli all’ex vicepresidente Riech Machar, di etnia Nuer, esonerato a luglio a causa dei forti contrasti con Kiir. A dicembre 2014, almeno 50.000 persone erano state uccise nel corso di questo conflitto etnico.
La Corte Penale Internazionale e ‘’l’incidente sudafricano’’
Nel luglio 2008, il procuratore della Corte penale internazionale, Luis Moreno Ocampo, ha accusato al-Bashir di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. La situazione in Darfur è stata analizzata dalla CPI molto attentamente e per molto tempo, fino alla decisione del 2008 che portò a spiccare il mandato di cattura. Il 4 marzo 2009, la Corte ha emesso un mandato di arresto per al-Bashir per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, ma stabilì anche che non vi fossero sufficienti prove per perseguirlo per genocidio. Successivamente, il 12 luglio 2010, tale sentenza venne modificata e la Corte emise un secondo mandato, contenente tre distinti capi d’accusa di genocidio. I capi d’accusa non affermano che Bashir avesse preso parte personalmente a tali attività, ma sostengono che sia “sospettato di essere penalmente responsabile, in quanto co-protagonista indiretto”. Alla decisione del tribunale si sono opposti l’Unione Africana e la Lega Araba.
Il nuovo mandato, come il primo, è stato consegnato al governo sudanese, che non ha riconosciuto né il mandato né la Corte penale internazionale. Il Sudan fa parte della lunga lista di Paesi che non riconoscono la Corte, insieme a Libia, Somalia, Giordania, Turchia, Egitto, Sud Sudan, Gibuti, Eritrea, Pakistan, Algeria, Iraq, Israele, Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Libano, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.
Nel giugno del 2015, il Presidente del Sudan si reca insieme ad altri leaders africani in Sud Africa, per il summit dell’Unione Africana. Il 14 giugno 2015, La Corte penale internazionale esorta il Sudafrica ad arrestare Al Bashir; in un primo momento, l’imbarazzo e la pressione sul Sud Africa sono fortissimi, e la giustizia sudafricana vieta a Bashir di lasciare il paese finché non si attueranno ulteriori verifiche e si sarà pronunciata sulla richiesta di arresto. Il 15 Giugno arriva la decisione dei giudici dell’alta corte sudafricana che ordina l’arresto del presidente Omar al Bashir. Sfortunatamente, il verdetto viene emesso qualche ora dopo la partenza di Bashir dall’aeroporto di Johannesburg, in violazione del precedente ordine; da qui una polemica che coinvolge varie autorità sudafricane, con i giudici amareggiati dal fatto che le autorità di polizia non hanno rispettato l’ordine di trattenere Bashir in Sudafrica.
Le proteste del 2018
A partire dal dicembre 2018, al-Bashir affronterà un diffuso malcontento che porterà la piazza a chiedere la sua rimozione dal potere. Le proteste antigovernative investivano diverse città e paesi del Sudan, la scintilla partita dall’aumento del costo del pane e del carburante, si è poi allargata alla richiesta di maggior trasparenza, alternanza politica e alla conseguente conclusione della trentennale presidenza di al-Bashir.
In meno di una settimana, le manifestazioni, iniziate il 19 dicembre nella città di Atbara, si sono rapidamente diffuse in tutto il Paese, compresa la capitale Khartoum.
L’11 aprile 2019, la situazione diventa insostenibile ed è l’elite militare a prendere in mano il potere, sollevando Bashir con un colpo di Stato militare. Nel settembre dello stesso anno, Bashir è sostituito dal Consiglio militare di transizione che trasferisce il potere esecutivo a un Consiglio di sovranità misto civile-militare e a un primo ministro civile, Abdalla Hamdok. Due mesi dopo, l’alleanza “Forze della Libertà e del Cambiamento” dichiarano che Bashir sarebbe potuto essere trasferito alla Corte penale internazionale. Nel dicembre dello stesso anno è stato condannato per corruzione a due anni di carcere. Inoltre, nel luglio 2020, un ulteriore processo è stato istruito contro di lui per il suo ruolo nel colpo di Stato che lo ha portato al potere nel 1989. Nel 2021, Al Bashir è consegnato dal governo sudanese all’Aja.
Il Consiglio militare di transizione (TMC)
Il Consiglio militare di transizione (TMC), rappresenta la giunta militare che governava il Sudan dalla rivoluzione d’aprile del 2019. Il 17 luglio il TMC formalmente guidato da Abdel Fattah al-Burhan, Ispettore delle Forze armate e l’alleanza Forze della Libertà e del Cambiamento (FFC) firmano un accordo di cooperazione politica. In questo scenario di fragile stabilità politica inizia a farsi largo Hamdan Dagalo, conosciuto come Hemetti, vice leader del Consiglio, comandante delle (RSF) Forze di supporto rapido e di conseguenza detentore del reale potere all’interno del Consiglio. A capo dei Janjaweed durante la guerra in Darfur , è stato nominato generale di brigata nelle nuove forze di supporto rapido (RSF) dal governo 1989-2019 di Omar al-Bashir. Dal 10 giugno 2019 , è un latitante accusato di crimini di guerra , crimini contro l’umanità e genocidio da parte della CPI.
La RSF è stata creata nel 2013 sotto la guida di Hemetti, da ex gruppi di combattenti Janjaweed, molti dei cui leader e sostenitori ( Ahmed Haroun , Ali Kushayb , Abdel Rahim Mohammed Hussein , oltre ad al-Bashir) sono stati incriminati per guerra crimini della CPI.
Le RSF si sono rivelate essere l’organizzazione immediatamente successiva alle milizie janjāwīd che una parte dei vertici militari mira a far assorbite all’interno della struttura militare statale e conseguentemente legittimare.
Gli accordi del 2019 prevedevano il trasferimento dei poteri a un nuovo organismo noto come Consiglio di sovranità e ad altri organi statali di transizione. Nonostante la vittoria del fronte per il cambiamento, il 2019 è contraddistinto da varie tappe di incertezza e instabilità, come dimostrano varie dichiarazioni del Governo rispetto ad elementi di spicco sudanesi che rifiutano il nuovo ordine, affermando che ‘abbiamo sventato più di un colpo di stato e i responsabili sono stati arrestati’’.
Il 12 luglio 2019, Gamal Omar del TMC ha riferito di quattro tentativi di colpo di Stato solo nei primi 7 mesi del 2019 e che a seguito di essi dodici ufficiali dell’esercito e del National Intelligence and Security Service (NISS) sono stati arrestati.
La ‘’nuova guerra’’ del 2023
L’instabilità è la condizione che ha maggiormente contraddistinto gli ultimi 4 anni di transizione del paese guidato da una leadership mista civili/militari. La continua trattiva tra le parti sul futuro della leadership del paese è stata la condizioni che ha si permesso lenti progressi nello sviluppo del territorio ma che ha anche esasperato gli animi e irrigidito le posizioni di ambo le parti, arrivando nel febbraio di quest’anno alla rottura definitiva dei rapporti tra esse.
Se l’FFC ha rappresentato, sin dal 2019, la speranza del cambiamento per i sudanesi, i componenti del TMC hanno visto la rivoluzione sudanese come un’opportunità per destituire Al Bashir che ormai aveva fatto il suo tempo. Contestualmente non hanno di certo messo, fra le priorità, gli obiettivi legati ad una democratizzazione del Paese e un miglioramento delle condizioni della povera popolazione sudanese. Durante il colpo di stato, Hemetti e Burhan hanno formato, progressivamente, un fronte comune per estromettere i civili alla guida del paese. Col passare del tempo, tuttavia, Hemetti ha costantemente denunciato il colpo di stato. Anche di recente si è schierato con i civili – quindi contro l’esercito nelle trattative politiche – bloccando le discussioni e quindi ogni soluzione alla crisi in Sudan. Per giorni i civili e la comunità internazionale hanno dovuto accettare un nuovo rinvio della firma dell’accordo politico che avrebbe dovuto far uscire il paese dall’impasse – a causa delle divergenze tra i due generali. Già nel mese di marzo, non c’erano prospettive concrete e positive sulla firma dell’accordo per aprire il processo politico che avrebbe dovuto riportare i civili al potere in Sudan.
La tensione si è progressivamente avvertita, e per giorni tra la popolazione della capitale Khartoum si sono rincorse voci di un imminente scontro tra i due campi. Già il 13 Aprile l’esercito aveva denunciato un “pericoloso” dispiegamento di paramilitari a Khartoum e in altre città senza “il minimo coordinamento con il comando delle forze armate”.
Le divergenze tra i due uomini forti del Sudan riguardano soprattutto il futuro dei paramilitari. Il nodo riguarda soprattutto quello del ruolo delle forze armate e la loro composizione: fra i punti chiave della transizione democratica, esiste la richiesta dell’integrazione delle RSF nelle truppe regolari: l’esercito non ha mai del tutto rifiutato questo compromesso, ma alle sue condizioni e con l’obiettivo velato di limitarne l’integrazione dei suoi effettivi. Hemetti, invece, rivendica un’ampia inclusione di tutti gli RSF e, soprattutto per lui stesso, un ruolo centrale all’interno dello stato maggiore. Come gia evidente in altri paesi del Nord Africa, l’esercito ha sempre svolto un ruolo fondamentale nel Paese e detiene buona parte del potere politico ed economico.
Dalla parte della società civile, i comitati di resistenza e l’Associazione dei professionisti sudanesi, all’ origine della rivoluzione del 2019, ripetono di rifiutare qualsiasi accordo con i soldati golpisti e infatti non hanno fermato, regolarmente, le manifestazioni contro l’attuale regime di lunga transizione militare.
Sembra quindi chiaro che il punto chiave sia sciogliere il nodo delle forze armate, sia da un punto di vista di composizione interna (questione degli RSF), sia sul piano politico, per quel ruolo fondamentale che ha sempre visto i militari sostenere il dittatore: una netta separazione di poteri sancita dalla fine della transizione e dalla dal potere politico porterebbe il paese sul cammino della democrazia, metterebbe fine al regime dei golpisti e, soprattutto, ridarebbe fiato all’economia che sta vivendo una crisi senza precedenti e aprirebbe, nuovamente, la strada a interventi delle istituzioni finanziarie internazionali necessari per avviare riforme fondamentali per la vita stessa del paese. La comunità internazionale, infatti, ha chiesto il ritorno alla transizione per riprendere gli aiuti al Sudan, cessate il fuoco e salvaguardare i civili. Se le parti in causa avessero raggiunto un accordo, la tabella di marcia prevedeva l’entrata in vigore della Costituzione provvisoria e la formazione di un nuovo governo civile, già entro questo mese, invece di mancare un’occasione storica e piombar in un nuovo conflitto con molte vittime civili anche straniere, che porterà sgradite conseguenze aii rapporti internazionali per il Sudan.
Marco Tamburro
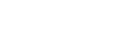

Add a Comment