
Abstract
LA TEORIA DELLE FINESTRE ROTTE. Dalla New York di Rudolph Giuliani al dibattito politico-sociale sulla sicurezza. Il disordine e il degrado hanno sempre costituito motivo di turbamento e di insofferenza in quanto incidono negativamente sulla qualità della vita di gran parte della popolazione. All’indignazione poi si accompagna spesso il timore che i comportamenti incivili, se non sufficientemente contrastati, possano pregiudicare la sicurezza in quanto le ripetute infrazioni alle regole del viver civile si trasformerebbero col tempo in reati ben più gravi quali furti, rapine e violenze varie. Di queste dinamiche si è occupato, nel 1982, un famoso articolo pubblicato sulla rivista “The Atlantic Monthly” scritto dai criminologi statunitensi James Q. Wilson e George L. Kelling e intitolato “Broken Windows. The police and neighborhood safety” (Finestre rotte. La polizia e la sicurezza del quartiere). I due studiosi partono dal principio per cui “se la finestra di un edificio viene infranta e non è riparata, le finestre rimanenti saranno presto rotte”. In altri termini, se si lasciano impuniti gli atti di inciviltà che incidono negativamente sulla qualità della vita e sulla sicurezza degli abitanti del quartiere, esiste il serio rischio che l’intero territorio divenga teatro di infrazioni sempre più gravi, se non di veri e propri crimini, divenendo in breve tempo invivibile per i cittadini. La teoria, chiamata appunto “Broken Windows Theory” (letteralmente: Teoria delle finestre rotte) deve la sua celebrità soprattutto al fatto di essere diventata il principio ispiratore della politica di “Tolleranza zero” attuata negli anni ’90 da Rudolph Giuliani, sindaco di New York, all’epoca in vetta alla classifica delle città più pericolose del pianeta. Alle misure messe in atto, che comprendevano la prevenzione e la severa repressione di trasgressioni che costituivano ormai la norma, quali gli atti di vandalismo e lo scavalcamento dei tornelli delle stazioni della metropolitana, corrispose un clamoroso quanto inaspettato calo dei crimini, compresi omicidi e rapine. Successivamente, i principi enunciati da Wilson e Kelling influenzarono alcune importantissime politiche di pubblica sicurezza applicate in Europa, come il progetto “Polizia 2000” realizzato in Spagna, il programma di “bonifica degli Champs-Elysées” a Parigi e il “Crime and Disorder Act”, posto in essere nel Regno Unito verso la fine degli anni ’90 dal governo laburista di Tony Blair. In Italia, invece, la legge n. 81 del 25.03.1993 aveva introdotto l’elezione diretta del sindaco, conferendo al primo cittadino poteri e competenze molto più ampie rispetto al passato, tanto da creare così i presupposti per un altro importante intervento normativo, vale a dire la legge n. 125 del 2008 (dichiarata tre anni dopo parzialmente illegittima sul profilo costituzionale), divenuta celebre con il nome di “pacchetto sicurezza”, che conferiva ai sindaci ampie potestà legislative in materia di sicurezza, decoro, viabilità e danneggiamento del bene pubblico. A quarant’anni dalla pubblicazione dell’articolo sul “The Atlantic Monthly”, la Teoria delle Finestre Rotte continua ad essere al centro del dibattito politico e sociale sul problema dell’ordine e della sicurezza, provocando reazioni e giudizi spesso contrastanti. Da un lato vi è chi considera questa teoria come profondamente reazionaria, ispirata ad una logica puramente repressiva e tesa a penalizzare i ceti più deboli della popolazione. Dall’altro c’è, viceversa, chi considera i principi enunciati da Wilson e Kelling come delle verità inconfutabili, empiricamente dimostrate. Tra i principali sostenitori della Teoria delle Finestre Rotte si sono sempre distinte le forze di Polizia, che le riconoscono il merito di “fotografare” in maniera chiara ed esaustiva situazioni da esse ben conosciute in base all’esperienza fatta “sul campo”, nello svolgimento dei propri compiti. Il presente lavoro, che prende le mosse dall’articolo del 1982, descrive e analizza la teoria e i suoi presupposti scientifici e culturali per poi proseguire con la descrizione delle sue principali applicazioni pratiche, soffermandosi soprattutto sull’attività del New York Police Department durante i due mandati di Rudolph Giuliani. Un intero capitolo è poi dedicato alla legislazione e al dibattito sull’ordine e la sicurezza pubblica in Italia a partire dagli anni ’70. Successivamente, vengono passate in esame le principali critiche alla “Broken Windows Theory”, con particolare risalto a quelle collegate alle denunce di violazioni ed abusi che sarebbero stati perpetrati dalla polizia newyorkese nel periodo della “Tolleranza zero”. L’obiettivo è, oltre che esporre in maniera quanto più possibile esaustiva la teoria, quello di sottolineare la necessità di distinguere tra le idee di Wilson e Kelling e le “Policies” che ad esse si sono ispirate, al fine di giungere ad una valutazione della “Broken Windows Theory” quanto più obiettiva e libera da pregiudizi e capire se essa possa ancora rappresentare una valida risposta all’inciviltà e al degrado che, soprattutto nelle grandi città, rappresentano delle criticità sempre più evidenti e condizionanti.
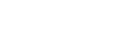
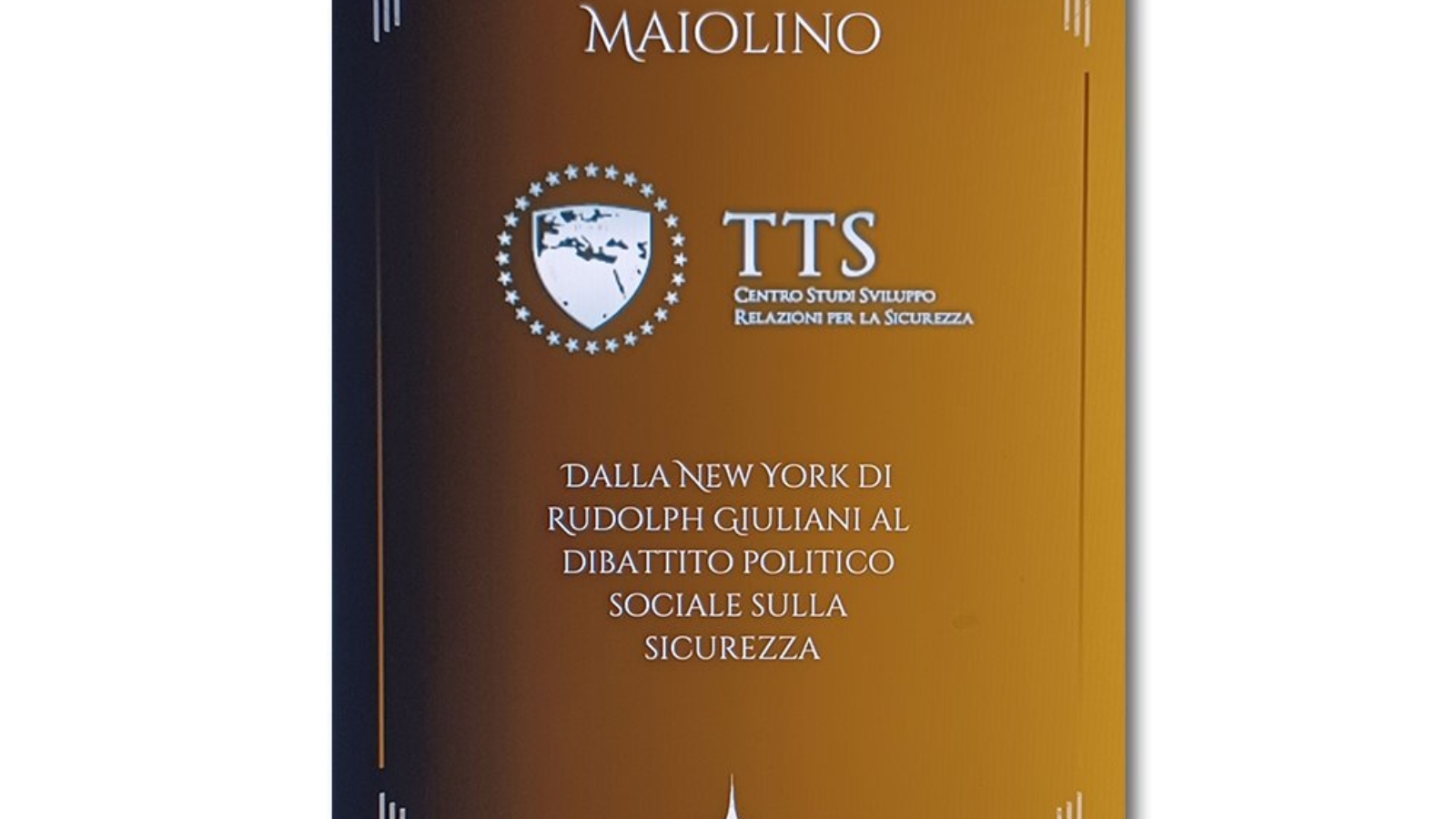
Add a Comment