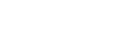Fonte: Conferenza sull’intelligenza artificiale Bruxelles 28-29 gennaio 2024
Giustizia
Per quanto riguarda il tema dell’intelligenza artificiale applicata alla giustizia nell’ambito dei lavori della Camera, si segnala, in primo luogo, la recente approvazione da parte dell’Assemblea, nella seduta del 28 settembre 2023, in sede di esame del disegno di legge di conversione del DL 105/2023 (A.C. 1373-A), dell’ordine del giorno 9/1373-A/56 Enrico Costa, con il quale la Camera impegna il Governo, nell’ambito della più ampia dimensione del riconoscimento della prova «vocale», ad introdurre le opportune modifiche delle norme processuali al fine di istituire una specifica procedura, anche attraverso una puntuale forma di incidente probatorio, in fase di indagine o di udienza preliminare e su richiesta di parte, al fine di garantire l’effettuazione di una perizia in caso di sospetti sull’alterazione di file audio o video per mezzo di sistemi di intelligenza artificiale, attesa la facile reperibilità di sistemi e applicazioni basati sull’intelligenza artificiale in grado di replicare la voce di chiunque a sua insaputa.
Si segnala, inoltre, l’interrogazione a risposta immediata in Commissione al Ministro dell’interno 5-01444 Magi sulle direttive del Ministero in materia di riservatezza dei dati relativi ai partecipanti alle manifestazioni pubbliche, svolta nella seduta della Commissione Affari costituzionali dell’11 ottobre 2023, nella quale l’interrogante ha chiesto cosa prevedano nel dettaglio le policies delle Forze dell’ordine, e quali siano le direttive del Ministero, in materia di riservatezza dei dati relativi a soggetti presenti a manifestazioni e ripresi in operazioni di ordine pubblico, anche al fine di evitare, tra l’altro, che i dati, e in particolare le immagini, possano essere utilizzati in software e sistemi di intelligenza artificiale in violazione della normativa vigente.
Nella risposta il Governo ha assicurato che il trattamento dei dati avviene in conformità a quanto stabilito dal D.M. 24 maggio 2017 e dal D.P.R. 15/2018 e che sulla conformità di tali disposizioni alla normativa vigente si è pronunciato il Garante per la privacy. Nella risposta, inoltre, il Governo ha precisato che “le immagini video raccolte dalla Polizia di Stato non sono sottoposte a elaborazioni informatiche a fini identificativi”.
Si segnala, infine, che presso la Commissione Giustizia del Senato, il 23 novembre 2023, è stata deliberata un’indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia. Una proposta analoga è stata avanzata presso la Commissione giustizia della Camera.
Difesa
Nell’ambito della Difesa, la Commissione IV della Camera dei deputati ha deliberato, nella seduta dell’8 novembre 2023, lo svolgimento di un’indagine conoscitiva su nuovi profili e criticità relativamente alla difesa cibernetica.
La difesa cibernetica si sostanzia in uno spettro di competenze dello Stato di natura prettamente militare, da inquadrare in una più ampia strategia nazionale per la sicurezza cibernetica, che a sua volta è intensamente integrata con l’Intelligenza Artificiale, tramite l’adozione sempre più frequente di strumenti e tecniche basati sull’Intelligenza Artificiale.
Proprio nella consapevolezza della rapida evoluzione e obsolescenza dello stato dell’arte nella materia, la Commissione Difesa, nel predisporre il programma dell’Indagine conoscitiva, ha previsto un campo di indagine quanto più ampio e flessibile possibile, in modo da coprire ogni eventuale esigenza informativa che si presentasse in corso d’opera.
Si ricorda infine che il dominio cibernetico e quello aero-spaziale sono stati inseriti, a livello normativo (articolo 88 del Codice dell’ordinamento militare), tra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale, insieme ai domini tradizionali (terrestre, marittimo e aereo).
Cultura
Innanzi alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione) è in corso di svolgimento una indagine conoscitiva sull’impatto della digitalizzazione e dell’innovazione tecnologica sui settori di competenza dell’organo.
Come evidenziato all’atto di deliberare l’avvio dell’iniziativa, lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie digitali e di internet, che hanno conosciuto un impetuoso sviluppo a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, con il nuovo millennio sono venute ad assumere dimensioni quantitative e qualitative tali da investire ogni ambito della vita umana, ridefinendo modelli e paradigmi in campo sociale, economico, culturale e politico (c.d. digital disruption). L’impatto trasformativo della digitalizzazione è stato tale da spingere gli studiosi di diversi ambiti disciplinari a indicare come “era digitale” l’epoca presente, ascrivendo a tali sviluppi una valenza paragonabile a quella dei progressi e delle innovazioni che segnarono la rivoluzione industriale. Lo scenario appena delineato – all’evidenza – rientra sotto molteplici profili nei settori di competenza o, comunque, d’interesse della VII Commissione: ciò sia per gli specifici e distinti temi di cui essa si occupa (cultura, istruzione, università, ricerca di base, sport, editoria); sia, in una logica più complessiva, per l’attenzione da essa tradizionalmente prestata alla dimensione antropologica e umanistica dei fenomeni, la quale, nel caso della digitalizzazione, è assai rilevante, se non addirittura prevalente, attesa la sua capacità d’imprimere mutamenti profondi negli schemi culturali e relazionali degli individui e delle collettività. L’indagine conoscitiva ha due obiettivi, fra loro sinergici. Il primo è quello di aprire una sede di confronto istituzionale con i soggetti pubblici e privati, le realtà nazionali e internazionali, gli operatori di settore, gli accademici e gli esperti per guidare un processo condiviso di emersione, perimetrazione e definizione dei temi, dei problemi e degli interessi in campo. Il secondo è quello di procurare alla Commissione dati, materiali istruttori e contenuti indispensabili per valutare, promuovere e adottare le conseguenti iniziative politiche e legislative, che, in un clima di aperto e costruttivo confronto fra tutte le Istituzioni, possano massimizzare per il nostro Paese i benefici della digitalizzazione, preservandone al contempo le peculiarità legate ai valori e al patrimonio che rendono l’Italia unica sul piano mondiale.
Nell’ambito dell’indagine, ad oggi il tema dell’intelligenza artificiale, sotto diverse angolazioni, è stato toccato principalmente, in ordine cronologico, nelle audizioni di Roberto Sergio (amministratore delegato della RAI), di Giampaolo Rossi (direttore generale della RAI), di Carlo Bartoli (presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti), di Edoardo Montefusco (presidente di Radio Dimensione Suono SpA), di Massimo Pellegrino (partner responsabile dei processi di innovazione digitale di Intellera Consulting), di Francesco Angelo Siddi (presidente di Confindustria Radio Televisioni), di Salvatore Giordano (legale del gruppo SIMAR), di Mirko Tavosanis (professore associato di linguistica italiana e presidente dei corsi di studio in informatica umanistica dell’Università di Pisa), di Federico Ferrazza (direttore di Wired Italia), di Enzo Mazza (presidente e amministratore delegato della Federazione industria musicale italiana), di Stefano Da Empoli (presidente dell’Istituto per la competitività – I-COM), di Paolo Marzano (professore di Diritto della proprietà intellettuale e di Tutela della proprietà intellettuale presso la Facoltà di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma), di Alessandro Giuli (presidente della Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo), di Padre Paolo Benanti (professore di teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana) e di Roberto Sommella (direttore di Milano Finanza).
L’indagine conoscitiva è in corso di svolgimento e non è dunque ancora stato approvato un documento conclusivo.
Si ricorda poi che presso la VII Commissione è stato avviato il dibattito connesso alla risoluzione 7-00185 presentata da Alessandro Amorese (FdI) che impegna il Governo, anche alla luce del quadro normativo europeo in corso di definizione, ad assumere iniziative per garantire il rispetto del diritto d’autore, la tutela dei dati personali, la trasparenza e la tracciabilità dei contenuti generati mediante intelligenza artificiale.
Infine, risulta depositata la proposta di legge A.C. 1514 (Ascani e altri, PD), recante “Disposizioni per assicurare la trasparenza nella pubblicazione e diffusione di contenuti prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale”. Il testo, di cui non è stato ancora avviato l’esame, consta di 3 articoli.
Per quanto qui interessa, l’art. 2 prevede che tutti i contenuti prodotti mediante sistemi di IA devono essere chiaramente identificati come tali e resi riconoscibili agli utenti attraverso l’apposizione di etichette e di filigrana. I soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di IA, in ogni mezzo trasmissivo, devono fornire, all’inizio e alla fine del contenuto, un’etichetta e un avviso visibili e facilmente comprensibili agli utenti che indichino che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce le modalità attraverso le quali i soggetti responsabili della pubblicazione e della diffusione dei contenuti prodotti mediante sistemi di IA, in ogni mezzo trasmissivo, devono rendere riconoscibile agli utenti che il contenuto è stato creato, in tutto o in parte, da un sistema di intelligenza artificiale.
Attività produttive
Innanzi alla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) è in corso di svolgimento una indagine conoscitiva dal titolo: “sull’intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano”.
L’indagine conoscitiva, come chiarito nel programma approvato il 3 agosto 2023, è volta a restituire un quadro organico dello stato dell’arte nell’applicazione dell’IA nel sistema industriale italiano e della regolamentazione vigente, con l’intento di proporre soluzioni normative adeguate, a descrivere le opportunità, le criticità e i rischi che l’implementazione dell’IA nei processi produttivi comporta, a rilevare in che modo l’IA possa diventare strategica per lo sviluppo delle attività imprenditoriali, a valutare i principali ostacoli alla competitività delle imprese italiane in rapporto al digital-gap che ancora interessa il nostro sistema produttivo, in particolare il sistema delle PMI, a individuare le metodologie di impiego dell’IA che possano supportare il commercio, l’artigianato e il turismo, a valutare l’impiego 2 dei fondi PNRR per investimenti nell’innovazione, compresa l’intelligenza artificiale, nonché a valutare l’incidenza dei nuovi fenomeni globali per quanto riguarda l’impiego dell’IA nelle realtà imprenditoriali.
Il programma dell’indagine conoscitiva, tuttora in corso, prevede che intervengano in audizione rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria e realtà rappresentative del settore, esperti provenienti da atenei e istituti di ricerca, nonché le associazioni dei consumatori.
Nel corso delle audizioni sin qui tenute, è emerso come l’intelligenza artificiale possa contribuire ad aumentare la produttività delle imprese operanti nei diversi settori e trovare applicazione lungo tutta la catena del valore, ottimizzando l’utilizzo delle materie prime, i processi di trasformazione, così come le attività di marketing e nei rapporti commerciali con i clienti, soprattutto nell’ambito dell’e-commerce ma non solo. Sono stati riportati anche esempi che dimostrano come l’IA possa utilmente essere utilizzata per migliorare la sicurezza sul lavoro e degli asset aziendali, così come per meglio garantire la conformità di operazioni e contratti tra privati ai diversi ordinamenti giuridici. È stato inoltre evidenziato come l’intelligenza artificiale, soprattutto generativa, possa – a differenza delle tecnologie dell’automazione tradizionale – migliorare i servizi prestati dalle professioni intellettuali.
Per cogliere tali opportunità, occorre però investire in formazione permanente sia per rafforzare le competenze utili allo sviluppo di tali tecnologie, sia per consentirne la diffusione e un uso consapevole da parte delle imprese, in particolare le PMI, che spesso non hanno le risorse finanziarie, manageriali e umane per investire e impiegare al meglio i sistemi di intelligenza artificiale. Un aspetto affrontato è anche quello della opportunità di adottare a livello europeo e nazionale un approccio strategico allo sviluppo di banche dati e sistemi di intelligenza artificiale, così da ridurre la dipendenza da tecnologie importate dai grandi attori globali.
I soggetti auditi hanno poi rilevato come alcuni rischi connessi al ricorso all’intelligenza artificiale debbano essere valutati dal legislatore e dalle amministrazioni pubbliche competenti per assicurare un quadro normativo adeguato. In particolare, è stato posto l’accento sulla necessità di garantire la trasparenza e l’affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale attraverso attività di certificazione e regole che consentano di spiegare le modalità di funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, così da evitare i bias e i pregiudizi che possono incidere sulle decisioni assunte avvalendosi di tali tecnologie, avere piena consapevolezza dei limiti e della qualità dei dati processati dai sistemi di IA e salvaguardare la privacy e i diritti dei consumatori. Altro compito della regolamentazione, che pur non deve tradursi in un ostacolo allo sviluppo e alla diffusione dell’intelligenza artificiale, inerisce alla corretta ripartizione delle responsabilità tra l’impresa che sviluppo il sistema di intelligenza artificiale e l’impresa che se ne avvale.
Infine, risultano depositate e assegnate alle commissioni X e IX le
proposte di legge:
• A.C. 1084 (Centemero ed altri, Lega), recante “Disposizioni concernenti l’adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”. La proposta di legge, che consta di due articoli, disciplina la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività che impiegano sistemi di intelligenza artificiale, al fine di promuovere l’innovazione e di consentire lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi nel territorio nazionale (art. 1). A tal fine, l’articolo 2 prevede l’adozione di uno o più regolamenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione, che ha una durata massima di diciotto mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, relativa all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale volti al perseguimento dell’innovazione di servizi e di prodotti nei diversi settori. Istituisce, infine, presso la Presidenza del Consiglio, un Comitato permanente per l’intelligenza artificiale;
• A.C. 1444 (Cannata e altri, FdI), recante “Disposizioni concernenti la fornitura e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale”. La proposta di legge, composta da 14 articoli, reca disposizioni in materia di:
a) immissione nel mercato, messa in servizio e uso dei sistemi di IA nel territorio nazionale;
b) trasparenza dei sistemi di IA destinati a interagire con le persone fisiche, dei sistemi biometrici e dei sistemi di IA utilizzati per generare o manipolare immagini nonché contenuti audio o video;
c) non conformità o divieto di determinate pratiche dei sistemi di IA;
d) creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività che sviluppano i sistemi di IA, al fine di verificarne e valutarne l’impatto nel territorio nazionale;
e) istituzione del Comitato nazionale per i sistemi di IA presso la Presidenza del Consiglio.
Lavoro
Lo scorso 28 settembre 2023, la XI Commissione Lavoro ha deliberato di svolgere un’indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.
Nel programma dell’indagine si sottolinea che tali impatti possono dare luogo ad un primo effetto integrativo a carattere positivo, nel quale si teorizza che i sistemi di intelligenza artificiale generativa saranno in grado di integrare le mansioni ed i compiti delle persone incrementandone la produttività e causando una riduzione di posti di lavoro limitata, e ad un secondo effetto sostitutivo a carattere negativo, nel quale si teorizza una massiva sostituzione di lavoratori i cui compiti, in special modo quelli routinari e quelli ad alta connotazione intellettuale, saranno progressivamente sostituiti da un massiccio ricorso alla tecnologia, con effetti dirompenti non verificati sui livelli occupazioni in seno alle economie più moderne.
Dati raccolti a livello nazionale e sovranazionale confermano la necessità di indagare e governare con urgenza questo cambiamento per evitare in primis l’acuirsi di disuguaglianze produttive e competitive all’interno del sistema Paese, anche in termini di valore aggiunto per ora lavorata, ed in una seconda fase individuare i potenziali rischi del sistema Paese connessi ad eventuali processi di massiva ristrutturazione.
Tale indagine conoscitiva è quindi finalizzata alla comprensione e alla verifica delle proposte, delle prospettive e dei risultati dell’impatto dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie all’interno del lavoro, nel breve e nel medio termine, nonché all’approfondimento di ogni aspetto relativo al rapporto tra tecnologia e lavoro, con lo scopo di tracciare un punto di fatto e sollecitare una produzione normativa, che sappia incrementare la produttività delle aziende, rilanciando l’economia, nonché proteggere il mercato del lavoro nella direzione di una crescita economica socialmente responsabile.
La Commissione ha deliberato di svolgere, in seno a tale indagine conoscitiva, un ciclo di audizioni – che ha avuto inizio con l’audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone (26 ottobre 2023) – particolarmente ampio ed articolato, che prevede il coinvolgimento di diversi soggetti interessati dalla tematica.
Di seguito un riepilogo delle audizioni finora svolte nell’ambito dell’indagine conoscitiva in oggetto:
• Prof. Guerino Nuccio Bovalino, Chercheur associé presso il LEIRIS – Laboratoire d’Études Interdisciplinaires sur le Réel et les;
• Imaginaires Sociaux de l’Université Paul Valéry-Montepellier, Francia (9 novembre 2023);
• Igor Bailo, Executive Director Data & Analytics di Engineering ingegneria informatica Spa (9 novembre 2023);
• Francesca Bitondo, Direttrice rapporti istituzionali, Microsoft Italia (9 novembre 2023);
• Prof. Francesco Fabrizio Delzio, Direttore del Master in Relazioni Istituzionali, Lobby e Human Capital della Luiss Business School (9 novembre 2023);
• Claudia Trivilino, Public Policy Manager, Italy and Greece di META (9 novembre 2023);
• Mauro Macchi, CEO di Accenture Italia (14 novembre 2023);
• Lelio Borgherese, Presidente di Assocontact (14 novembre 2023);
• Prof. Daniele Nardi, Direttore del Laboratorio Nazionale Artificial Intelligence and Intelligent Systems del CINI (15 novembre 2023);
• Andrea Orlandini, organizzatore della 22esima Conferenza internazionale dell’associazione italiana per l’intelligenza artificiale, e di Chiara Ghidini, vicepresidente dell’associazione italiana per l’intelligenza artificiale (15 novembre 2023);
• Emanuela Girardi, Board member di Adra – AI, Data and Robotics Association (15 novembre 2023);
• Alessandra Santacroce, Direttore Relazioni Istituzionali di IBM Italia
S.p.A. (16 novembre 2023);
• Avv. Chiara Ciccia Romito, dottoranda di ricerca in «Lavoro, Sviluppo e Innovazione», Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Fondazione Marco Biagi (16 novembre 2023);
• Roberto De Ioris, programmatore e docente di programmazione presso l’Accademia Italiana Videogiochi (16 novembre 2023);
• Rita Cucchiara, professore ordinario di «Computer vision and Cognitive systems» presso il Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»;
• dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (16 novembre 2023);
• Giovanni Paolino, presidente di Avedisco, e Giuliano Sciortino, Segretario generale di Avedisco (22 novembre 2023);
• Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (22 novembre 2023);
• Marco Trombetti, cofondatore e CEO Translated – Pi Campus (22 novembre 2023);
• Prof. Stefano Crisci, avvocato esperto di IA e professore di Market Regulation e Diritto del turismo e del governo del territorio presso l’Università La Sapienza di Roma (22 novembre 2023);
• Carlo Cosolo, consigliere di ADID (Associazione direttori italiani doppiaggio), e di Daniele Giuliani, presidente di ANAD (Associazione nazionale attori doppiatori) (6 dicembre 2023);
• Francesco Verbaro, Senior Advisor di AdEPP (6 dicembre 2023);
• Fosca Giannotti, professore ordinario di informatica presso la Scuola Normale Superiore (6 dicembre 2023);
• Stefano da Empoli, presidente di I-Com (6 dicembre 2023);
• Aldo Forte, responsabile Personale ed organizzazione di ENEL Spa. (13 dicembre 2023);
• Francesco Rutelli, Presidente di ANICA (13 dicembre 2023);
• Francesca Boccia, Coordinatrice Commissione nazionale sull’Intelligenza Artificiale di Federmanager (13 dicembre 2023);
• Chiara Trifino, addetta alle relazioni industriali di Conflavoro PMI (13 dicembre 2023);
• Cesare Damiano, presidente dell’Associazione Lavoro & Welfare (20 dicembre 2023);
• rappresentanti di Confprofessioni: Carlo Girella, relazioni istituzionali dell’ufficio studi (20 dicembre 2023);
• Marco Carlomagno, Segretario generale di FLP – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, e di Roberto Cefalo, responsabile area politiche contrattuali di FLP (20 dicembre 2023);
• Alberto Lucarelli, professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Napoli Federico II (20 dicembre 2023 rappresentanti dell’Associazione EGAIR (10 gennaio 2024);
• Armando Tursi, professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Milano (10 gennaio 2024);
• Matteo Flora, professore a contratto in Corporate reputation presso l’Università degli studi di Pavia (10 gennaio 2024);
• Giuseppe Attardi, professore ordinario di Informatica presso l’Università degli studi di Pisa (10 gennaio 2024).
Il termine per la conclusione dell’indagine conoscitiva è il 31 marzo 2024.
Affari sociali
Presso la Commissione XII (Affari sociali) i temi dell’Intelligenza artificiale sono stati affrontati in primo luogo, sia pure in maniera indiretta, con riferimento alla digitalizzazione in ambito sanitario, obiettivo della Missione 6 (Salute) cui sono destinate risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, in termini di nuovo Fascicolo sanitario elettronico (circa 1,67 miliardi di euro): da un lato, per il trattamento, condivisione ed interoperabilità di grandi dati acquisiti grazie all’accesso garantito a tutti i cittadini alle piattaforme dei servizi, e dall’altro. di Telemedicina e cure domiciliari (circa 4 miliardi) per assicurare un’assistenza sanitaria personalizzata, in particolar modo per i pazienti fragili.
Sul tema della Telemedicina è stata poi discussa nella seduta del 5 dicembre 2023 l’interrogazione a risposta immediata in Commissione 5- 01699 (MORGANTE Maddalena), in particolare sugli aspetti della televisita di pazienti affetti da malattie croniche come la sclerosi multipla, a cui il Governo ha risposto confermando l’intenzione, in accordo con gli obiettivi del PNRR, di implementare una rete infrastrutturale per connettere le strutture mediche tra loro e con i pazienti nello loro unità remote.
Va infine ricordato che è attualmente all’esame della Commissione XII, la risoluzione in Commissione 7-00183 (LOIZZO Simona), diretta ad impegnare il Governo a definire una normativa in grado di sfruttare pienamente il potenziale dei dati sanitari, tutelando il consenso, la privacy e la sicurezza dei cittadini, e individuando tra le finalità della proposta di regolamento comunitario sullo “spazio europeo dei dati sanitari” (cd. EHDS
– European Health Data Space), quella di garantire l’accesso delle persone ai propri dati sanitari elettronici ed un maggiore controllo di tali dati, a livello nazionale e transfrontaliero, per assicurare l’omogeneità dei dati nell’ambito del mercato unico dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche, dei dispositivi medici e dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio (cd. “uso primario dei dati”).
Sul tema l’Ufficio di Presidenza della Commissione ha deliberato di audire la direzione generale del Ministero della salute, l’Istituto superiore di sanità, l’Agenas, l’Istat, il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni dei pazienti: le audizioni si svolgeranno nel corso delle prossime settimane.
Affari comunitari
La XIV Commissione Politiche dell’UE non ha trattato espressamente degli sviluppi dell’intelligenza artificiale nelle sue attività ma tali tematiche sono comunque emerse nell’ambito dell’articolato ciclo di audizioni informali svolto in relazione all’esame, ai sensi dell’art. 127 Reg. Camera, della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell’UE (Join (2022) 49 def) (assegnata, in sede primaria alle Commissioni riunite IV e IX), tuttora in via di svolgimento.
In particolare tra i soggetti che hanno fatto riferimento alle questioni legate all’IA nel corso delle audizioni si segnalano:
• i rappresentanti di Google Italia e di Apple Italia (12 aprile 2023);
• i rappresentanti di IBM Italia (3 maggio 2023);
• i rappresentanti di Hewlett Packard Enterprise – HPE Italia (3 maggio 2023);
• i rappresentanti di CISCO (31 maggio 2023);
• i rappresentanti di Samsung Electronics Italia (21 giugno 2023);
• i rappresentanti di DELL Technologie (21 giugno 2023);
• il prof. Federico Faggin (6 luglio 2023).
Si rappresenta, inoltre, che nelle prossime settimane, la XIV Commissione inizierà a trattare del tema dell’Intelligenza Artificiale, nell’ambito dell’esame, della Relazione della Commissione europea sul controllo dell’applicazione del diritto dell’UE nel 2022 (COM(2023)453 final), nella quale una sezione è intitolata “Un’Europa pronta per l’era digitale”.
Comitato per la documentazione
Il Comitato di vigilanza per l’attività di documentazione, già nella scorsa Legislatura, ha iniziato a lavorare sul tema dell’intelligenza artificiale ritenendo che l’uso delle nuove tecnologie nel campo della conoscenza possa fornire un utile apporto anche allo sviluppo della documentazione parlamentare.
Durante la Legislatura in corso, il Comitato ha ripreso il lavoro su tale tematica con l’avvio di un’indagine conoscitiva, sviluppatasi a oggi nell’arco di dodici sedute, nell’ambito della quale sono stati auditi:
• Prof. Paolo BENANTI della Pontificia Università Gregoriana; Prof.ssa Rita CUCCHIARA dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
• Prof. Maurizio FERRARIS dell’Università di Torino; Prof. Gianluca MISURACA dell’Università politecnica di Madrid;
• Dott. Pier Luigi Dal Pino, Senior Regional Director Government Affairs Western Europe, Microsoft;
• Dott. Mattia De Rosa, Direttore dell’unità specialistica Data & AI, Microsoft;
• Dott. Alessio DEL BUE della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; Nestor MASLEJ AI Index Research Manager dell’Università di Stanford;
• Anna MAKANJU, Head of Public Policy, OpenAI; Boris POWER, Head of Partnerships Research, OpenAI;
• Prof. Gianfranco BASTI, professore ordinario di Filosofia della Natura e della Scienza presso la Pontificia Università Lateranense;
• Naila MURRAY, Head of FAIR (Fundamental AI Research) Emea Lab META; Angelo MAZZETTI, Head of Public Policy Italy and Greece META;
• Michael Sellitto, Head of Global Affairs, Anthropic; Orowa SIKDER, Technical Lead on Applied Research, Anthropic.
Il 14 febbraio 2024 il Comitato presenterà il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva. Nell’occasione, verrà attivato un hackathon, aperto a centri di ricerca e operatori del settore, per lo studio e lo sviluppo di sistemi da impiegare nell’ambito dell’attività di documentazione.