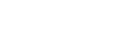L’83% dei programmi gestiti dall’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), in un’epurazione da sei settimane, ha ufficialmente eliminato interi programmi di assistenza emergenziale e per lo sviluppo che avevano richiesto decenni di lavoro.
Il Segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato i massicci tagli lunedì, confermando che circa 5.200 dei 6.200 programmi globali di USAID sono stati chiusi. Le iniziative superstiti – meno di un quinto del precedente portafoglio di aiuti americani – saranno assorbite dal Dipartimento di Stato. ‘’ Finanziamo i programmi indipendentemente dal fatto che siano allineati o meno con la politica estera. È ridicolo…’’ : ovviamente dipende dalla prospettiva e i criteri che si usano, considerando che gli Stati Uniti hanno ‘’scelto’’ di investire circa 9.9 miliardi di dollari solo nel 2024 per i piani di risposta umanitari elaborati dalle nazioni Unite in tutto il Mondo che sicuramente non influivano direttamente sulla politica americana, ma miravano a salvare milioni di vite attraverso programmi d’urgenza.
Si potrebbero citare anche i cento miliardi complessivi investiti nel programma PEPFAR creato da George W. Bush e che ha sempre ricevuto un voto bipartisan al suo finanziamento. La nuova amministrazione ha annunciato la sospensione degli aiuti in concomitanza con l’ordine di ritirare gli Stati Uniti dal coordinamento globale sui programmi sanitari e climatici e con la minaccia di coinvolgere gli alleati europei in una guerra commerciale. La decisione è legata comunque anche al panorama di politica interna, considerando la priorità dell’amministrazione Trump di ridurre la macchina e le spese federali.
L’improvviso congelamento degli aiuti esteri statunitensi è diventato un chiaro avvertimento del cambiamento dell’approccio degli Stati Uniti all’impegno globale e fa pressione sui governi europei per contenerne le conseguenze. Collettivamente, l’Unione Europea è tra le maggiori fonti di aiuto allo sviluppo del mondo, con oltre 52 miliardi di dollari all’anno. Sul breve periodo, forse la mossa può effettivamente essere interpretata come una sfida indiretta all’Europa che potrebbe dover aprire un nuovo fronte di negoziati e sforzi politici e finanziari, per colmare il gap lasciato scoperto dai fondi americani, soprattutto sul continente africano.
Dall’altra parte, uno scenario possibile, per quanto cinico e molto poco etico, potrebbe vedere gli Stati Uniti tornare a negoziare in bilaterale con ogni partner africano dei possibili aiutati ma legati alle concessioni sulle risorse naturali di ogni stato e i vantaggi economici delle imprese americane.
In questo caso l’Unione Europea si troverebbe a intrattenere rapporti con gli Stati africani ma in competizione con la nuova postura statunitense votata solo agli affari, finanziare le ONG e le Nazioni Unite per i programmi umanitari e di sviluppo senza offrire i vantaggi economici che il competitor americano offrirebbe. Con una disponibilità finanziaria sempre più ridotta a fronte del nuovo riarmo sul fronte dell’Est Europa, l’Unione Europea dovrà dimostrare molta unione e anche cercare di coinvolgere più direttamente dei Paesi che potrebbero parzialmente sostituirsi agli Stati Uniti nel finanziamento dei programmi di sviluppo e emergenze, come Emirati Arabi, Qatar e Arabia Saudita.
Questi Paesi, in realtà, hanno già aumentato i loro contributi e coinvolgimento nell’assistenza umanitaria, come l’Arabia Saudita che ha contribuito nel 2024 con 1.2 miliardi di dollari ai piani di risposta umanitari, seguita anche dagli Emirati Arabi con 787 milioni, il Qatar con 483 milioni e il Kuwait con 51 milioni[1].
Diversificare gli interlocutori e aprire nuove forme di finanziamento e dialogo sembra essere l’unica strada per l’Unione Europea per far fronte alla nuova aggressività e ostilità americana, che ridisegna il panorama internazionale.
Marco Tamburro
[1] https://fts.unocha.org/global-funding/donor-grouped/2024?order=total_funding&sort=desc