L’offensiva verso la capitale della provincia del Nord Kivu, Goma, da parte dell’M23, è stata rilanciata a gennaio di quest’anno dopo diversi mesi di calma apparente. A dispetto delle dichiarazioni ufficiali, l’apparato militare dell’M23, moderno e sofisticato, viene finanziato da tempo dal Rwanda. Ci sono voluti solo pochi giorni, fra il 23 e il 28 gennaio, per prendere prima l’aeroporto e poi i punti chiave di Goma. Ai primi di febbraio, è toccato poi anche a Bukavu, capitale del Sud Kivu, cadere nelle mani dei ribelli rwandesi con una precipitosa ritirata anche degli altri contingenti burundesi e sudafricano.
Se l’Unione Africana e la SADC hanno cercato di avviare dei negoziati direttamente col Rwanda per cercare una soluzione diplomatica, la regione resta una grande polveriera. Se il Rwanda ha delle chiare mire sul controllo dei Kivu per ragioni di sicurezza interna e grande presenza di materie prime, dall’altra parte il Burundi si trova in una posizione di estrema fragilità: geograficamente, al momento il Burundi si trova con un movimento pro-Rwanda come l’M23 alle porte del Paese dislocato su tutta la frontiera, oltre al confine chiuso da tempo col Rwanda. Facile immaginare come l’M23, se volesse, avrebbe facile accesso a vari punti della frontiera fra Rwanda e Burundi per sfruttare la debole presenza dell’esercito burundese in vari punti. Se però, a questo punto, un attacco imminente non sembra essere previsto, potrebbe anche non essere necessario se si volesse arrivare, in un altro modo, ad avere un nuovo regime politico molto più favorevole a Kigali. In Burundi, una storica minoranza tutsi ha in mano la maggior parte dell’economia e dell’esercito, a fronte della maggioranza della popolazione di etnia hutu. Inoltre, c’è da considerare anche la presenza della milizia Red-Tabara (Résistance pour un État de Droit au Burundi), milizia ribelle formatasi nel 2015 in seguito alla crisi politica del Paese e sostenuta sempre dal Rwanda.
In questo quadro la leadership hutu del Burundi, guidata da Évariste Ndayishimiye, sente tutta la pressione che si aggiunge alla precaria situazione del Paese: penuria di carburante, potere di acquisto delle famiglie sempre più ridotto, malnutrizione cronica e insicurezza alimentare esacerbati dal rifiuto politico di riconoscere questa situazione come vera crisi umanitaria.
In questo quadro ONG e agenzie UN lavorano da diversi anni per mitigare la crisi cronica del Paese, ma sono anche attenti alla sicurezza del loro personale se la situazione dovesse precipitare. Proprio per questi motivi, a metà febbraio, la rappresentante del programma alimentare mondiale (WFP) aveva diffuso delle istruzioni di sicurezza interne al PAM sui social media. In queste istruzioni, il WFP invitava il suo personale a fare scorte di cibo, acqua e carburante per due settimane; una raccomandazione ritenuta allarmistica dalle autorità burundesi, che l’hanno vista come un tentativo di seminare il panico tra la popolazione. Per questo motivo, Il governo ha deciso di espellere la rappresentante del WFP, e la responsabile della sicurezza dell’organizzazione che hanno lasciato il Paese il 14 febbraio.
In questo clima, è facile percepire che la presenza delle forze burundesi prima sul territorio dell’RDC e poi in posizioni difensive, oltre alla presenza del contingente sudafricano che si è ritirato dall’RDC, continuino a generare tensioni col Rwanda; nonostante ciò, il 3 febbraio, il presidente Ndayishimiye ha annunciato un patto di non belligeranza che dovrebbe scongiurare un’aggressione del Rwanda, ma non si sa se questo includa anche l’M23. La tensione però non diminuisce infatti, il 27 febbraio, durante un comizio pubblico a Bukavu, alla presenza di Corneille Nangaa, leader dell’M23, due distinte esplosioni hanno fatto undici morti; il leader dell’M23 ha affermato che le granate utilizzate nelle esplosioni sono dello stesso tipo di quelle usate dall’esercito del Burundi nella RDC.
Nei prossimi mesi, sarà ovviamente fondamentale capire quale sarà l’evoluzione del conflitto fra M23 e RDC, se le Istituzioni internazionali sanzioneranno il Rwanda e se gli altri attori regionali saranno in qualche modo colpiti da conseguenze indirette. Nello specifico contesto del Burundi, si delineerà meglio quale anima riuscirà a migliorare la posizione del Paese, se si arriverà ad una normalizzazione dei rapporti col Rwanda o se la questione etnica esacerberà i conflitti interni come in passato.
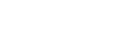

Add a Comment