I mandati d’arresto della Corte penale internazionale e l’immunità per i Capi di Stato e di Governo: dal caso al-Bashīr al caso Putin
Con un comunicato stampa del 17 marzo 2023, la Corte penale internazionale ha reso noto di aver emesso un mandato d’arresto nei confronti del Presidente della Federazione Russa, Vladimir Vladimirovich Putin, e della Commissaria per i diritti dell'infanzia presso l'ufficio del Presidente della Federazione Russa, Marija Alekseyevna L’vova-Belova, con l’accusa di crimini di guerra di deportazione e trasferimento illegale di popolazione, in particolare bambini, dalle aree occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa.
Ma cosa vuol dire, nello specifico? Quali effetti, all’atto pratico, possono avere questi mandati d’arresto? E poi: cos’è e in base a quali presupposti agisce la Corte penale internazionale?
Nel tentativo di offrire una risposta a questi e ad altri interrogativi, appare opportuno operare una descrizione del percorso storico che ha condotto alla “instaurazione”, nel 1998, della Corte penale internazionale, nonché anche una rappresentazione delle attività poste in essere dalla Corte da quando ha iniziato la sua attività nel 2002, soffermandosi su alcuni “casi” che hanno permesso l’affermazione di taluni principi fondamentali su cui basare le decisioni della stessa Corte.
Partendo dalle prime esperienze di “tribunali penali internazionali”, quali quello di Norimberga e di Tokyo, orientati a sottoporre a giudizio i responsabili dei più gravi crimini perpetrati nel corso della Seconda guerra mondiale, a loro volta ispirati dalle risultanze del Trattato di Versailles del 1919, che intendeva sottoporre a un processo sovranazionale l’imperatore tedesco Guglielmo II, accusato di crimini contro la pace e contro l’umanità, si giunge fino agli eventi della cosiddetta ”Operazione militare speciale in Ucraina” del 2022, nonché ai fatti immediatamente successivi, passando dallo storico evento legato alla convocazione della Conferenza dei plenipotenziari e alla firma dello Statuto di Roma nel 1998 (atto con cui è stata sancita la nascita della Corte penale internazionale) e dalle proteste dell’”Euromaidan” del 2014, di cui si analizzano le origini e le caratteristiche.
Si analizzano e si descrivono, inoltre, le prime attività significative della Corte, non solo in termini temporali ma anche e soprattutto per quel che riguarda la rilevanza che alcuni fatti attenzionati dalla stessa hanno assunto nelle sue determinazioni successive. A tal proposito, non si procede solo e soltanto ad esporre e analizzare le prime attività di indagine della Corte e le sue prime condanne o assoluzioni, ma si pone particolare attenzione agli eventi che hanno visto coinvolto l’ex Presidente del Sudan Omar Hasan Ahmad al-Bashīr, destinatario di due diversi mandati d’arresto da parte della Corte per crimini di guerra, contro l’umanità e di genocidio, che sarebbero stati posti in essere nel noto “teatro” del Darfur nel corso dell’omonimo conflitto.
Esaminando la specifica circostanza e gli effetti che tali mandati di arresto hanno avuto sul piano internazionale, soprattutto alla luce di quanto (non) fatto in termini di cooperazione da parte di vari Stati parte dello Statuto di Roma, tra cui in particolare il Sudafrica, si arriva infine a trattare dei parallelismi e delle divergenze tra il caso al-Bashīr e il caso Putin, ponendo l’attenzione in particolar modo sul tema della responsabilità, con un focus sulle differenze tra i due diversi soggetti destinatari dei mandati d’arresto (Putin e L’Vova-Belova), nonché sulla questione delle immunità per i Capi di Stato e di Governo previste e regolate dagli articoli 27 e 98 dello Statuto di Roma.

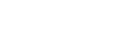
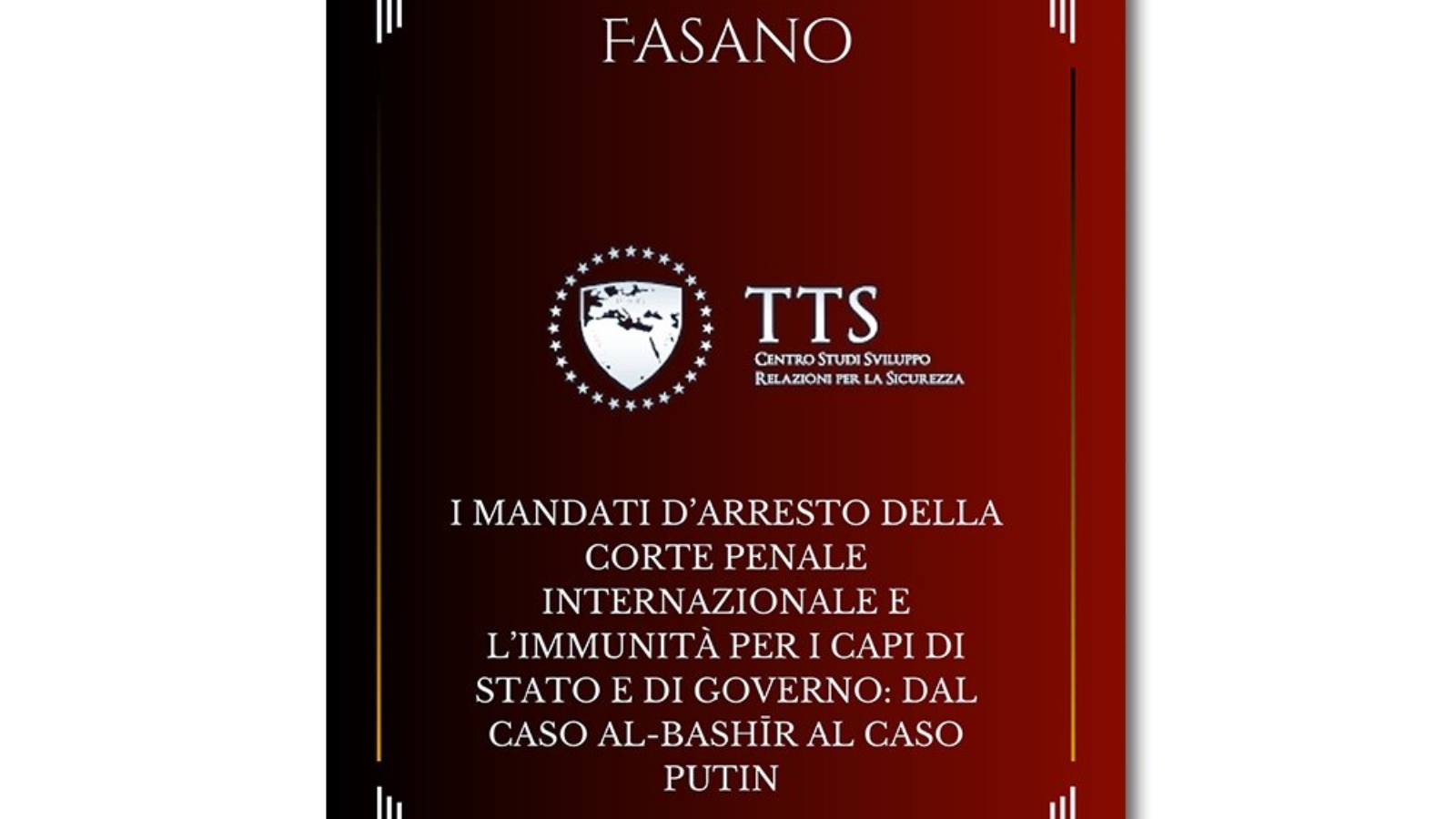
Add a Comment