Le scienze cognitive studiano il modo in cui opera, funziona e si comporta la mente umana. Come settore di studio scientifico, le scienze cognitive richiedono un’applicazione multidisciplinare si spazia dall’ambito filosofico allo psicologico, neuropsicologico, ma anche all’ambito medico, statistico-metodologico e organizzativo, fino ad includere studi che interessano i processi che legano l’uomo alla liberta di scelta e non da ultimo le interconnessioni con intelligenze non biologiche o IA.
Lo sviluppo di conoscenze teoriche e competenze applicative per l’analisi e la gestione di processi decisionali individuali e collettivi, sono sempre più coordinate nelle scienze cognitive per un approccio sistemico multidimensionale.
Lo studio interdisciplinare dei sistemi intelligenti, finalizzato alla comprensione del sistema cognitivo, sta con l’evoluzione dell’IA acquisendo nuova polarità all’interno non solo del settore accademico scientifico, ma anche nel dibattito quotidiano e nel pensiero comune. Le scienze cognitive attualmente stanno fornendo una base scientifico filosofica alla formazione e creazione di modelli simulativi di intelligenze non biologiche e reti neurali.
Il professor William Bechtel[1], ha definito le Scienze cognitive come “ lo studio interdisciplinare dei sistemi intelligenti – naturali e artificiali – che si avvale di contributi di discipline come la linguistica, la psicologia, l’intelligenza artificiale“.
Da quella definizione le scienze cognitive hanno continuato a espandere i proprio terreno di studio, andando a creare una rete di interconnessioni che oggi annovera tra le discipline interessate: la psicologia cognitiva, la neurofisiologia, la neuroscienza cognitiva, l’intelligenza artificiale (IA), la linguistica cognitiva, la filosofia della mente, nonché l’informatica (coinvolta soprattutto nella formazione di modelli simulativi come le reti neurali).
Branche della ricerca stanno cercando di applicare la metodologia e le teorie di studio e ricerca delle neuro scienze anche a indirizzi fino a questo momento esclusi.
L’antropologia, la genetica, l’etologia, l’economia (si pensi alla teoria dei giochi e il neuromarketing), la scienza cognitiva della matematica e persino all’arte.
In ogni caso ciò che qualifica principalmente le scienze cognitive sin dal loro nascere, vedi il MIT di Boston nel 1956, è il loro carattere tipicamente multidisciplinare, in grado di coniugare discipline anche molto differenti tra loro, al fine di giungere alla comprensione del funzionamento cognitivo.
Metodologia delle scienze cognitive
Attualmente gli scienziati cognitivi si occupano principalmente di modellazione e teorizzazione computazionale, nel tentativo di capire la mente, l’intelligenza e il funzionamento del concetto di pensiero. I principali centri di studio sono attualmente presso l’Università degli Studi di Milano, Roma tre a Roma, o la Chapman in California e l’Università del Texas a Dallas (solo per citare alcune eccellenze nazionali ed estere)
Tali studi prevedono la sperimentazione con soggetti umani, organizzati in gruppi, per simulare raggruppamenti sociali, o presi come singoli. Spesso sono gli studenti stessi che si prestano a partecipare a esperimenti di laboratorio riguardanti uno degli aspetti pratico/teorici delle Neuro Scienze, o la reazione dell’apparato a stimoli esterni studiati in condizioni (che si spera…) controllate.
Questi esperimenti in genere prevedono un ragionamento deduttivo, in cui i soggetti devono applicare idee con risultati pratici volti a convalidare o meno una tesi.
La scienza cognitiva è nata dal desiderio di comprendere non tanto chi siamo in termini filosofici ma per cercare di comprendere il “perché pensiamo”, le origini e motivazioni del ”comportamento umano” e se le nostre azioni o interazioni possano essere non solo un segno del nostro io, ma possano essere alterate da stimoli esterni o fisiologici.
Ampliando il campo
In ambito medico, man mano che si scopre di più sui percorsi neurali, sulle risposte psicologiche e psicosomatiche relative a stimoli sia interni che esterni e aumentiamo l’interrelazione con tecnologie come le IA, le scienze cognitive diventano sempre più chiarificatrici grazie ai progressi nelle tecniche e tecnologie di sperimentazione cognitiva, gli scienziati si avvicinano a scoperte che potrebbero curare malattie neurodegenerative debilitanti quali ad esempio il Parkinson.
L’universalità dei processi decisionali: i meccanismi neurocognitivi che si innescano nella presa di decisione
Il ragionamento universale innescato dall’approccio molteplice caratterizzante le Scienze Cognitive, ben si adatta al concetto di sicurezza che abbiamo sviluppato negli ultimi anni.
La cultura della sicurezza, oggi si basa su conoscenze approfondite in un mondo dominato dalla complessità della realtà. I cambiamenti rapidi del nostro tempo dovuti alla globalizzazione, e contraddistinti da un’accelerazione complessa degli eventi, richiede un approccio altamente interconnesso.
Il mondo odierno, e le società che lo compongono sono un sistema complesso in ogni suo aspetto e chi si occupa di sicurezza, a diverso titolo e grado, non può più operare senza tener conto delle varie sfaccettature e interconnessioni in tutti i settori della quotidianità. La maggior parte degli eventi si svolgono all’interno di sistemi dinamici complessi, imprevedibili, e ciò rende necessario sviluppare compiutamente il binomio consapevolezza/conoscenza secondo un approccio multidimensionale, tipico dei sistemi scientifici complessi, capace d’ integrare tutte le azioni umane.
Se la comprensione profonda dei processi cognitivi consente di analizzare e gestire i processi psicologici e decisionali, siano essi individuali che collettivi, l’applicazione di tale metodo consentirà un giorno di giungere a quella che viene definita “l’Equazione della sicurezza”.
La comprensione del pensiero, allo scopo di teorizzare principi fondamentali come: rappresentazioni mentali e meccanismi computazionali razionali e dimostrabili è un interesse emerso negli anni ’50. Un percorso razionale e dimostrabile (quindi prevedibile) può essere applicato alle scelte collettive proprie o indotte, che coinvolgono molteplici aspetti e sono determinanti nelle sorti di un’attività o della sicurezza di una collettività.
Lo studio delle scienze cognitive nei processi decisionali permette di analizzare e progettare interventi atti a migliorare la qualità e l’appropriatezza delle decisioni, riducendo il rischio di errore. Si tratta di una risorsa volta a supportare scelte in contesti complessi, in cui le ricadute delle decisioni, possono essere anche devastanti a livello sociale.
L’integrazione fra neuroscienze e scienze cognitive applicate, consente oggi di progettare percorsi basati sull’uso di strumenti tecnologici evoluti. Attraverso questi sistemi è possibile migliorare l’organizzazione del lavoro e buone pratiche che ne garantiscono la sicurezza e la stabilità per un benessere sociale condiviso: la tecnologia diventa così un sostegno ai processi decisionali. Le scienze cognitive evolvendo all’interno della società, che contribuiscono a plasmare, hanno aggiunto alle domande sull’agire, sull’arbitrarietà e deliberatezza del pensiero quelle collegate all’interazione di quest’ultimo con macchine e intelligenze artificiali.
Scienze cognitive e sicurezza allargata
Il processo decisionale si sintetizza nella scelta tra possibili soluzioni, derivanti da: intuizione o ragionamento (o entrambi).
Mentre sono aspetti personali a muovere l’intuizione del decisore e si basano su valori ed esperienze, fatti e dati certi ed oggettivi caratterizzano l’approccio ragionato.
Secondo uno schema classico il processo che porta a una decisione può essere riassunto in cinque fasi.
- Identificare l’obiettivo;
- Raccogliere informazioni;
- Trovare soluzioni;
- Valutare le conseguenze;
- Compiere la scelta.
Tali processi vengono influenzati dalla situazione di partenza:
- stato di certezza,
- stato di rischio,
- stato di incertezza,
ma anche dalle condizioni umane che hanno creato tali condizioni, e dalla misura in cui esse siamo spontanee o indotte da manipolazioni esterne, psicologiche, ambientali o materiali.
Grazie a questo livello di analisi il decisore, che tiene conto solo delle classiche 5 fasi e delle 3 variabili è in grado di conosce solo lo stato di fatto con un’analisi psicosociale della realtà che ha creato la situazione a cui è chiamato a rispondere, può valutare le probabili conseguenze delle sue scelte, capire e creare un modello di previsione e azione per evitare che tali condizioni possano ricrearsi.
Se da un lato l’analisi psicologica compiuta dalla “psicologia delle masse” mira a studiare l’influsso dei fenomeni collettivi sul comportamento individuale, le scienze cognitive mirano ad integrare ogni possibile aspetto indagabile alla ricerca delle interconnessioni che rendono possibili tali comportamenti, fornendo una spiegazione multidimensionale a problemi complessi che possono spaziare dal concetto di sicurezza allargata, all’influenzabilità del libero arbitrio, al rapporto con intelligenze non biologiche.
[1] William Bechtel, Filosofia della mente, Il mulino, 1992, ISBN 88-15-03684-9, OCLC 797567017. URL consultato il 16 dicembre 2022.
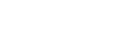

Add a Comment