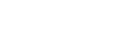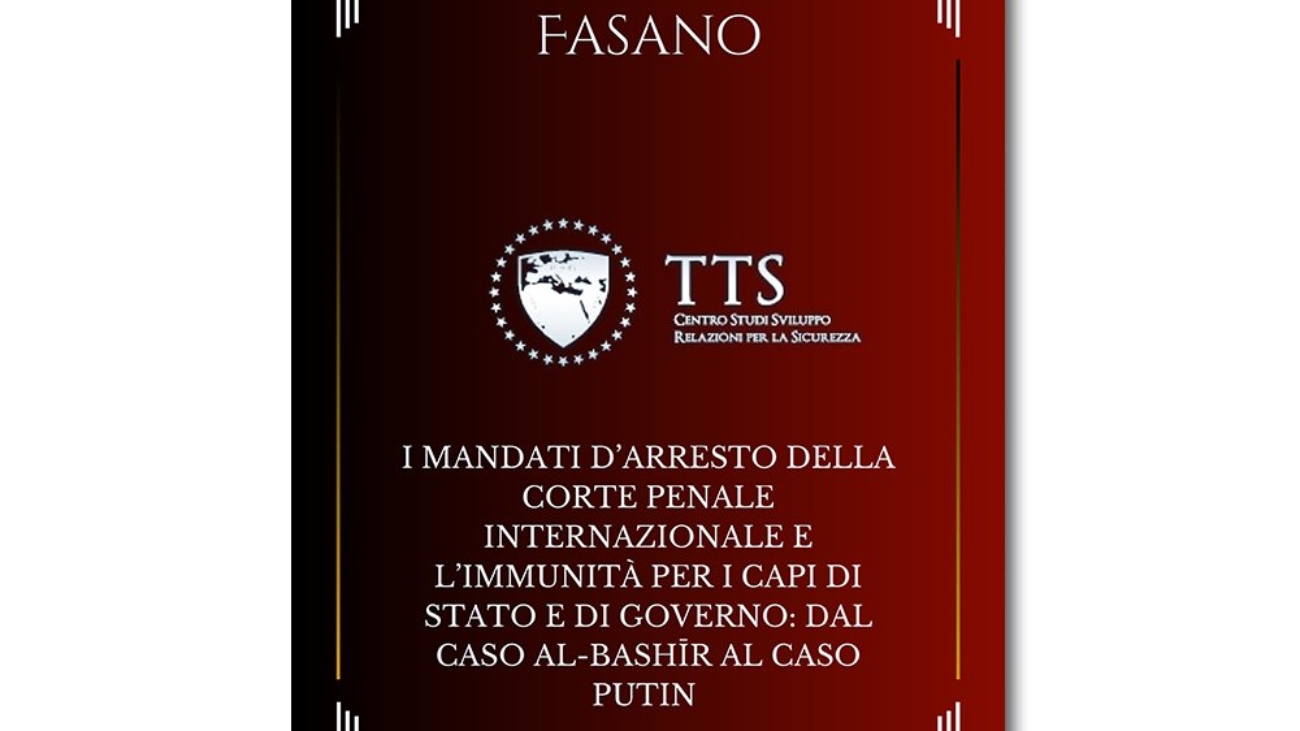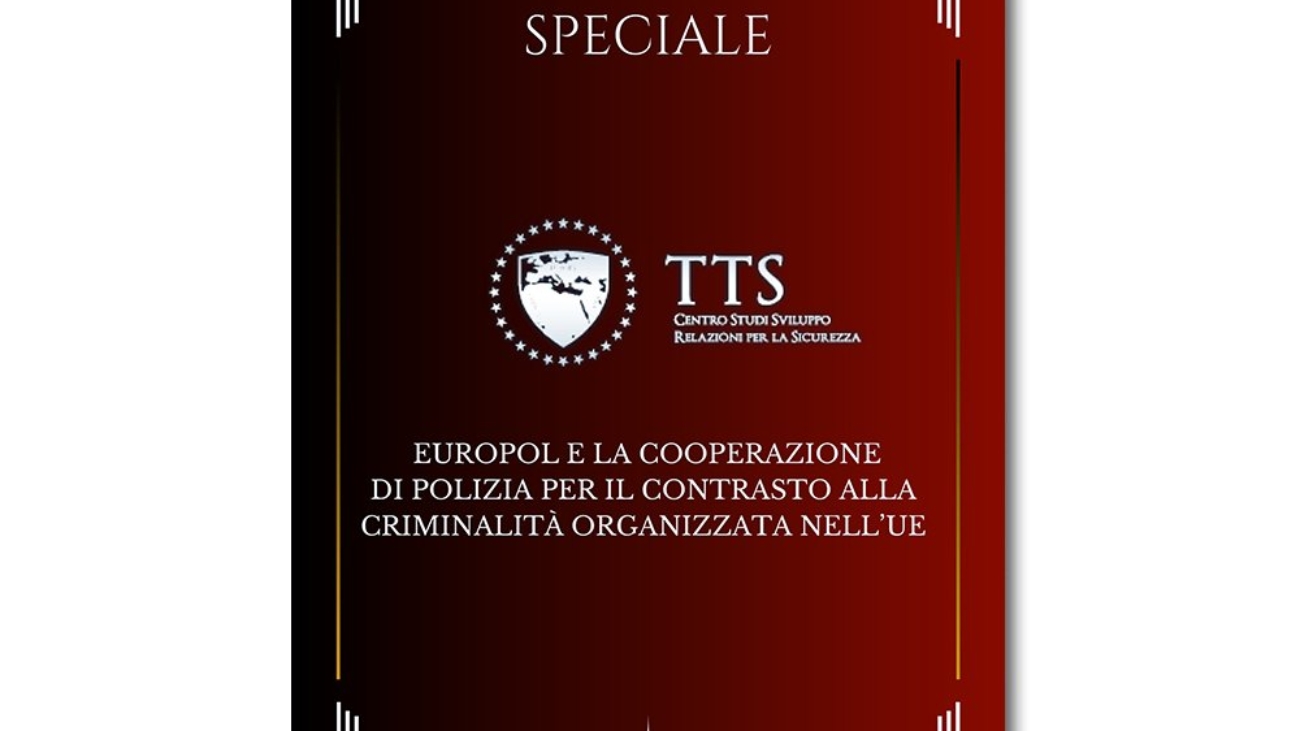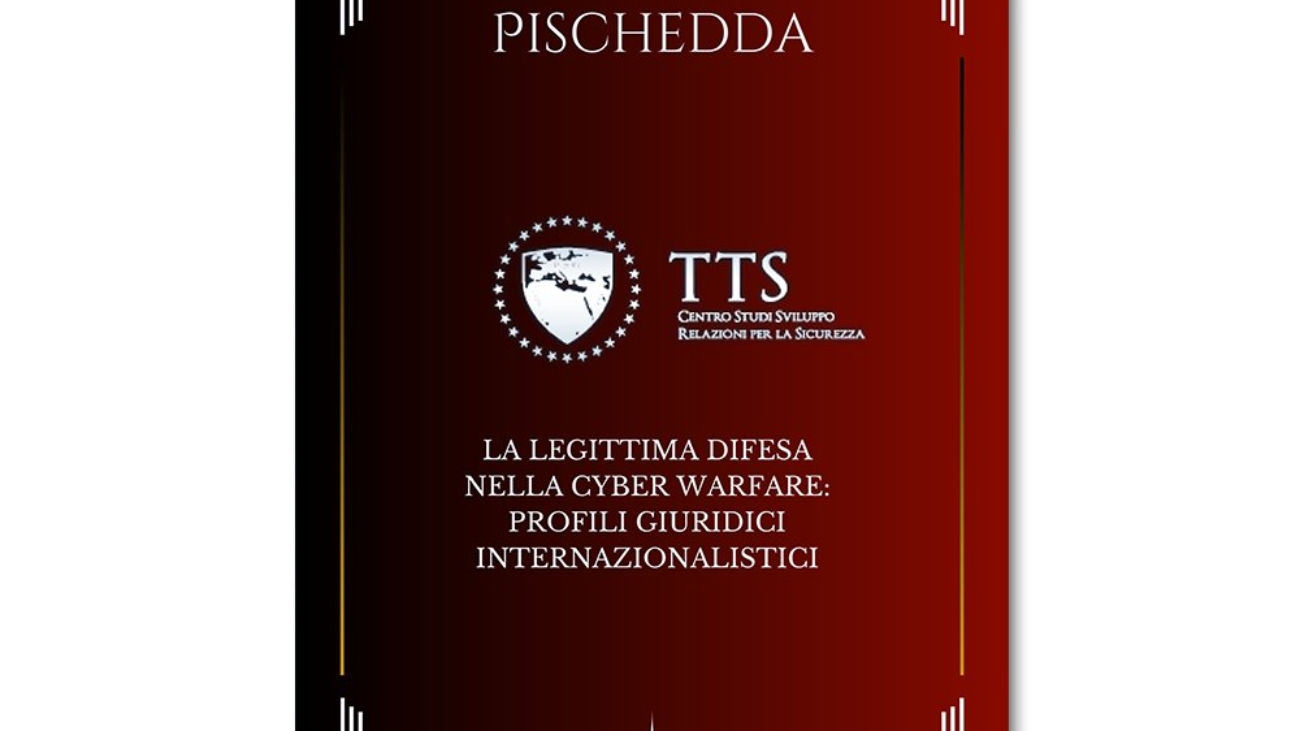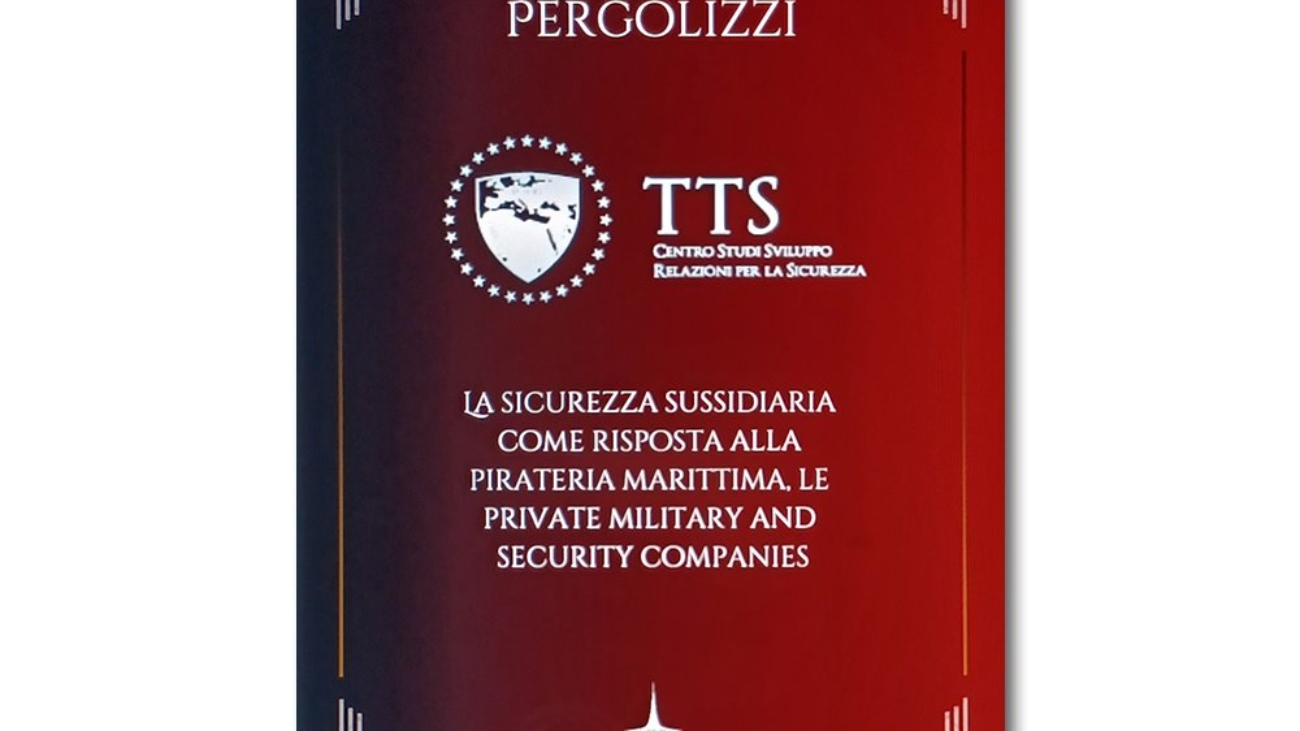Dott. Gaetano Fasano.
Laureato con lode in Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza presso l’Università degli Studi di Roma – Unitelma Sapienza. Funzionario presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, specializzato in attività antifrode e controlli, cooperazione internazionale e scambi informativi. Vanta una ultraventennale esperienza nella Pubblica Amministrazione, sia nel comparto sicurezza che nel comparto IT. Attualmente impegnato in percorsi formativi riguardanti le relazioni internazionali nel settore commerciale. La passione per le discipline internazionalistiche e per l’attualità sociopolitica, unita alla competenza lavorativa anche in ambito di polizia giudiziaria, lo hanno condotto ad approfondire gli sviluppi degli eventi del conflitto russo-ucraino, in particolare sul piano delle responsabilità penali e delle competenze in merito all’accertamento delle stesse da parte della Corte penale internazionale.