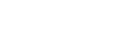La missione dei Paesi del Sud-Est dell’Africa (SADC) in Mozambico dovrebbe concludersi a luglio, ma alcune truppe rimarranno, poiché i Paesi vicini temono che l’insurrezione jihadista a Cabo Delgado stia riprendendo piede
Nel corso di tre anni, le forze della SADC hanno aiutato l’esercito mozambicano a riconquistare il territorio un tempo detenuto dai militanti e a stabilizzare Cabo Delgado per un certo periodo, ma visti i recenti attacchi di Aprile 2024, l’insurrezione è tutt’altro che debellata. In sostanza, la campagna militare pluriennale non è riuscita a infliggere un colpo decisivo e una recente recrudescenza degli attacchi, col graduale ritiro dei Paesi SADC, suggerisce che i combattenti si stanno riorganizzando.
A gennaio, la SADC ha dichiarato che avrebbe ritirato la forza alla scadenza del suo attuale mandato, il 15 luglio 24. Il Botswana e il Lesotho si sono ritirati ad aprile, mentre Angola e Namibia stanno progressivamente lasciando il paese secondo le scadenze previste.
Il Sudafrica, i cui 1.495 soldati costituiscono i due terzi della missione, sarebbero dovuti tornare a casa nelle prossime settimane, ma con una mossa a sorpresa, il 23 aprile, hanno annunciato che manterranno le sue forze di difesa a Cabo Delgado fino alla fine dell’anno. In effetti, lascerà 200 persone fino al marzo 2025 per affrontare “attività marittime illegali” lungo la costa del Mozambico.
Ad aprile, il Rwanda ha dichiarato di voler aggiungere truppe al suo dispiegamento di 2.500 uomini, secondo i termini di un accordo bilaterale segreto con Maputo. Apparentemente, anche la Tanzania vuole mantenere tra i 400 e i 500 soldati in Mozambico, soprattutto preoccupata per attacchi lampo che potrebbero essere organizzati fra gli 860 km di confine tra i due Paesi.
Di conseguenza, gli accordi militari in corso sembrano destinati a compensare la fine della missione SADC, ma regna l’incertezza sul quadro in cui opereranno le truppe straniere. I funzionari sudafricani affermano che Pretoria sta semplicemente prolungando il turno di servizio dei suoi soldati per organizzare un ritiro ordinato nel corso dell’anno. Le truppe tanzaniane potrebbero rimanere in base a un accordo bilaterale con Maputo o lavorare sotto la bandiera della SADC con il Sudafrica almeno fino a dicembre. In ogni caso, il ritiro delle truppe dei vari Paesi potrebbe comunque avvenire troppo presto rispetto all’attuale situazione.
Dal 2023 in poi, la campagna combinata ha compiuto notevoli progressi, riducendo il numero degli insorti da circa 3.000 a meno di 300, secondo i diplomatici regionali e gli analisti della sicurezza in Mozambico. Le truppe straniere hanno inoltre ripreso il controllo di un numero di aree, sufficiente da consentire il ritorno a casa di oltre mezzo milione di persone dislocate. Due leader militanti di alto livello, uno mozambicano e l’altro tanzaniano, sono scomparsi nel corso del 2023. Le autorità mozambicane, nel frattempo, hanno ripristinato alcuni servizi pubblici in alcune aree precedentemente controllate dagli insorti.
In generale, fra le varie difficoltà della SADC, esiste la mancanza di fondi per la missione. La missione ha, infatti, fatto molto affidamento sui contributi degli Stati membri, ma ha sempre avuto un deficit. Il Sudafrica è quello che ha dato di più, circa 45 milioni di dollari all’anno. Un contributo di 15 milioni di euro da parte del Fondo europeo per la pace per attrezzature non letali con attività di formazione, benché gradito, è stato insufficiente per sostenere operazioni di terra su larga scala. L’Unione Africana, da parte sua, ha fornito attrezzature, ma ha erogato solo circa 2 milioni di dollari attraverso l’Africa Peace Facility per la missione.
Oltre alle carenze finanziarie, la SAMIM ha affrontato diverse altre difficoltà: nonostante i primi successi operativi, le truppe hanno faticato a debellare i piccoli gruppi di militanti sparsi su un terreno accidentato. Sembra ovvio che i numeri della missione sono insufficienti per coprire la sua vasta area di responsabilità, che ha solo poche strade decenti. Le forze sudafricane non hanno quasi più elicotteri funzionanti e non sono in grado di condurre operazioni aeree. La mancanza di attrezzature affidabili e di pezzi di ricambio ha fiaccato il morale delle truppe, che preferiscono rintanarsi nelle loro basi piuttosto che dare la caccia a unità sempre più mobili di militanti.
Il rapporto di lavoro con le forze mozambicane a Cabo Delgado ha rappresentato un’altra sfida: scarsamente addestrati e sottopagati, i mozambicani si aspettavano che le truppe del Rwanda e della SADC prendessero il comando nell’affrontare gli insorti. Ufficiosamente, funzionari della SADC si sono lamentati amaramente della mancanza di comunicazione e cooperazione da parte dell’esercito mozambicano che, secondo loro, ha reso quasi impossibile la condivisione di informazioni. La SAMIM ha incontrato ostacoli simili nelle sue attività non militari.
L’esercito mozambicano continua inoltre a dover fare i conti con la carenza di materiale e con le difficoltà di rifornimento delle unità dislocate in avanti. Il governo ha chiesto all’Unione Europea più equipaggiamento militare, ma Bruxelles è riluttante ad accettare. Dal 2022, gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno addestrato forze di reazione rapida (QRF) nell’esercito, nella marina e nell’aeronautica. Le QRF dovrebbero assumere un ruolo di primo piano nella lotta agli insorti a partire da dicembre, ma gli scarsi risultati dell’esercito in termini di pianificazione e logistica fanno sì che queste forze speciali possano soffrire di una mancanza di supporto e rifornimenti critici una volta diventate operative.
Tuttavia, il governo di Maputo sembra abbastanza soddisfatto dello stato delle cose a Cabo Delgado, essendo più fiducioso dei Paesi vicini di poter respingere una recrudescenza jihadista con l’aiuto del Rwanda e, in misura minore, della polizia comunitaria.
La decisione di mantenere le truppe rwandesi nelle zone chiave di Palma e Mocímboa da Praia, nonché nei pressi delle miniere di grafite di Ancuabe, sembra chiaro che il governo ha fatto della salvaguardia delle sue rosrse naturali una priorità. Nell’ultimo anno, TotalEnergies ha valutato se riaprire il progetto del gas, ma la valutazione dell’azienda sulla situazione della sicurezza resta negativa. In caso di maggior mancanza di truppe, il progetto del gas potrebbe tornare a essere un bersaglio per l’insurrezione.
A questo punto l’ago della bilanca da un punto di vista militare, sembra essere il Rwanda; la sua presenza in Mozambico ha suscitato poche reazioni sul piano dei diritti umani, poiché le truppe rwandesi sono ben disciplinate e hanno un buon rapporto con i civili. Tuttavia, vari Paesi UE continuano a temere che Kigali stia intervenendo a Cabo Delgado non solo per stabilizzare la provincia, ma anche per promuovere i propri interessi economici; il Rwanda, attraverso Crystal Ventures, società che rappresenta il braccio d’investimento del partito al potere, è coinvolto in una serie di attività in Mozambico, tra cui l’estrazione mineraria, l’edilizia e la sicurezza privata.
Dal punto di vista del Rwanda, nuovi fondi UE sembrano l’unica soluzione per continuare l’intervento. In precedenza, il Rwanda ha già ottenuto un contributo di 20 milioni di euro dal Fondo europeo per la pace, in scadenza di rinnovo, ma gli Stati membri dell’UE sono in disaccordo sulla richiesta, dato il sostegno di Kigali al movimento ribelle M23 nella RDC orientale.
Marco Tamburro