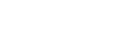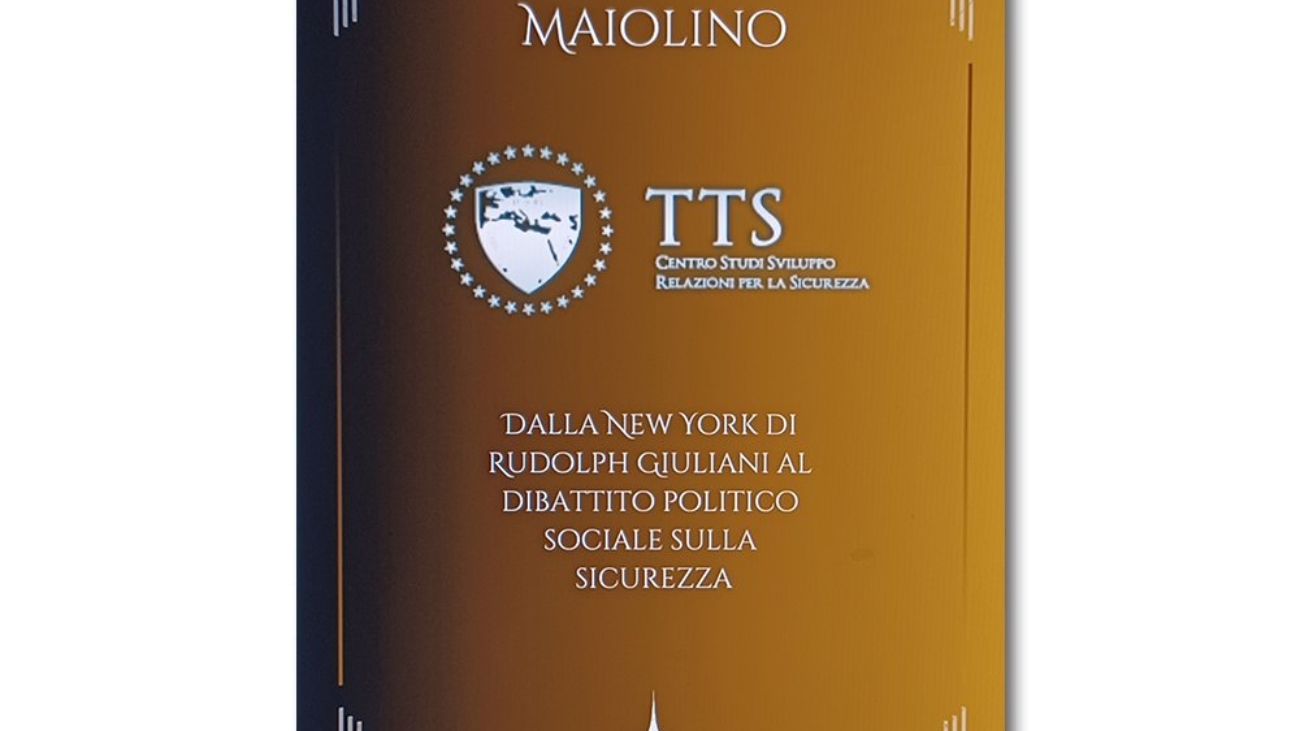Al 4 novembre 2024 sale a 17 il bilancio dei morti confermati negli scontri fra polizia e manifestanti per le strade delle maggiori citta mozambicane. Ai 17 deceduti sulle strade, si aggiunge anche l’omicidio per mano ignota di Elvino Dias e Paulo Guambe, esponenti di spicco del nuovo partito PODEMOS, maturoatis il 19 ottobre scorso. Proprio dalla formazione politica PODEMOS si deve partire per spiegare l’ondata di violenze dell’ultimo mese: dopo qausi trent’anni di guerra civile e processo di pace ormai concluso, le elezioni presidenziali 2024 potevano essere celebrate come le prime senza la presenza di un ala militare vicina ad uno dei partiti che concorrevano alla presidenza. Da sempre il Mozambico si è contraddistinto per il bipolarimso fra FRELIMO, uscita vincitrice dalla guerra civile e da sempre al potere, contro la RENAMO, che nel 2018 aveva perso il leader storico Alfonso Dhalakama. Da allora Ossufo Mohamade aveva ripreso la gudia della RENAMO ma nulla era cambiato a livello dei risultati elettorali: diversi i rapporti post-elezione di USAID e UE a seguito di osservazioni, avevano riportato, nelle varie tornate elettorali, un susseguirsi di frodi, brogli, intimidazioni e, in generale, nessuna separazione tra il Governo e il partito FRELIMO.
In questo quadro, la frustrazione del popolo mozambicano è crescuita, non solo nei riguardi del partito al Governo incapace di migliorare la situazione della maggior parte dei mozambicani, ma anche nei confronti della RENAMO che sembrava, negli ultimi anni, avere un ruolo di oppositrice fantoccio, perfettamente calata nella realtà di secondo partito del Paese senza maggiori aspirazioni. Certo, altri partiti avevano già raggiunto alcuni risultati significativi, come il Movimento democratico del Mozambcio (MDM) capace di assicurarsi da quasi 15 anni solo la municipalità di Beira, provincia di Sofala. L’MDM, come Podemos, naceva però proprio da scissioni interne alla RENAMO che ha visto perdere consensi fino ad essere, dopo le elezioni del 4 ottobre, il terzo partito in termini di presenze di deputati in Parlamento. Infatti, è stato Venancio Mondlane, candidato indiependente supportato dalla lista PODEMOS, a registrare i maggiori successi e a rivendicare anche una vittoria, quanto meno prematura, il giorno dopo del voto e quando si erano scrutinati meno del 10% dei seggi.
Secondo la CNE, commissione nazionale elettorale, alla fine si è imposta la FRELIMO con quasi il 75% dei consensi, guidata dal candidato Daniel Chapo, successore alla guida del partito dopo che Filpe Nyussi dovrà abbandonare l’incarico di Presidente della Repubblica dopo due mandati, conforme ai dettami costituzionali.
E’ proprio dopo il 4 ottobre, però, che cominciano a susseguirsi molte segnalazioni di brogli: imposizioni di esponenti della Frelimo di tener aperti i seggi fino a tarda notte per rivedere i risultati non favorevoli, episodi di supporto della polizia locale a traporti sospetti delle casse contenti le schede elettorali, schede dei seggi ricontrollate e con risutlati diversi in sede di conteggio finale. Sembra quanto meno strano che, dopo una campagna elettorale che aveva visto Venancio Mondlane contraddistinguersi come un candidato energico, pronto a sfidare la FRELIMO, si sia arrivati poi ad un risultato col 75% dei consensi per il partito uscente. Con i risultati elettorali e l’omicio dei due esponenti di PODEMOS, sembra che molte persone abbiano tradotto queste manovre come il segnale inequivocabile che nessun cambiamento o dissenso sarebbe mai potuto essere tollerato.
Verso fine ottobre, pare che Venancio Mondlane si sia reso prima irrintracciabile, poi protagonista di una rocambolesca fuga verso il Sud Africa da cui si collega ogni giorno in diretta live su Facebook per chiamare il popolo mozambicano allo sciopero generale, preparando, la tanto temuta marcia su maputo del 7 novembre. Da qui la situazione tesa ma anche grottesca che si respira a Maputo: nonostante la vittoria elettorale, la forza militare e di polizia nelle mani del Governo e quindi della FELIMO, Mondlane ha già lanciato due appelli allo sciopero generale che vedono diverse città funzionare parzialmente, con molte persone del settore dei trasporti aderire allo sciopero e persone comuni organizzare manifestazioni spontanee in vari quartieri, soprattutto a Maputo. La repressione anche di piccole proteste pacifiche è stata da subito molto dura con le vittime fra la popolazione, oltre anche ad almeno due agenti di polizia rimasti uccisi. Se in città si respira uno strano clima per la marcia del 7 novembre, l’annuncio ha anche dato al Governo il tempo di prepararsi e suidare misure preventive: al vaglio, tra l’altro, anche un possibile stato d’emergenza nazionale che potrebbe prevedere alcune settimane di copri fuoco e esercito nelle strade.
Poco più di un anno fa, il Presidente Nyusi parlava in plenaria all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 settembre 2023: “Concludo facendo appello all’esistenza di un sistema finanziario internazionale più inclusivo, guidato da regole trasparenti e reciprocamente vantaggiose […] Per raggiungere questo obiettivo, è necessario recuperare la fiducia e il rispetto reciproco tra gli Stati, che sono i principi sacri della Carta delle Nazioni Unite”…sono queste oggi, nel 2024, le premesse che l’Africa chiede?
Marco Tamburro