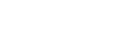La rivoluzione industriale segnò il punto d’inizio dello scollamento tra i ritmi della natura e quelli della società civile. L’avvento delle macchine per la produzione in serie porterà un cambiamento radicale nelle abitudini e nelle attività umane, cambiamenti che rappresentano oggi uno dei più potenti fattori di trasformazione dell’ambiente naturale.
In questi duecento anni il divario tra i ritmi della terra e quelli dell’uomo, hanno raggiunto una dimensione facilmente percepibile. Lo sviluppo tecnologico ed i suoi effetti sull’ambiente naturale nel primo e nel secondo mondo seguono ritmi, molto più veloci e spesso forzati, di quelli caratteristici degli ecosistemi naturali. Si può affermare che, i tempi geologici di evoluzione della terra e quelli biologici di evoluzione della natura a noi più vicini, risultano sempre più incompatibili con quelli dell’evoluzione tecnico-scientifica del genere umano.
Il divario nella scala dei tempi e lo sviluppo di tecnologie e prodotti ad alto potenziale inquinante, sono fattori di un modello di crescita orientato più al consumo che all’uso sostenibile delle risorse naturali. Questo tipo di impostazione culturale, ha generato un paradigma che determina oggi un degrado generalizzato delle componenti ecosistemiche e che comincia ad assumere caratteristiche di irreversibilità. L’economia classica e l’avvento del liberismo ci avevano spinto a credere che la terra, fosse un contenitore con infinite risorse e dall’illimitata capacità portante. Questa credenza ha impedito per anni un’analisi oggettiva delle risorse e delle capacità della terra.
Alla metà del secolo scorso un approccio più oggettivo alla realtà ha mostrato che il pianeta terra è in realtà un sistema chiuso, di dimensioni finite, vincolato a limiti biofisici, che non consentono una crescita infinita, né tantomeno un’immissione di rifiuti ed inquinanti oltre la sua capacità portante.
Responsabilità sociale e complessità ecologica
L’apprendere delle conseguenze nefaste delle attività dell’uomo sul sistema terra, ha favorito alla fine del novecento la nascita di un nuovo approccio allo sviluppo, incentrato non più sulla produzione ma sulla responsabilità sociale della stessa. Un approccio morale all’economia rappresenta il nuovo punto di partenza, per ridisegnare il progresso all’interno di un sistema che, coinvolga anche l’uomo e le sue attività.
Modelli etici di comportamento e norme di condotta, stanno caratterizzando un approccio che tenga presente standard di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Standard etici di comportamento per le imprese quali:
- Legittimità orale
- Equità ed uguaglianza
- Tutela della persona
- Diligenza
- Trasparenza
- Onestà
- Riservatezza
- Imparzialità
- Tutela ambientale
- Protezione della salute
rappresentano l’ossatura su cui si ipotizza dovremmo costruire la nostra nuova economia, coadiuvati da sistemi di controllo e monitoraggio volti più ad istruire che ad ammendare. In questo modello di produzione chi si trova nella posizione di decidere il futuro dell’attività è chiamato all’osservanza di doveri fiduciari nei riguardi degli stakeholder. La responsabilità sociale non consiste solo nel rispetto degli obblighi giuridici ma anche nell’investire in capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate.
Approccio inclusivo per uno sviluppo dinamico
Il concetto della terra come sistema chiuso ha plasmato non solo l’idea di uno sviluppo universalmente responsabile, ma anche di un approccio allo studio dei fenomeni naturali in termini di connessioni e relazioni all’interno di un contesto con regole ben precise. il concetto di pensiero sistemico che ne scaturì (F. Capra, 1997) può essere definito come: “un complesso di componenti interagenti” (von Bertalanffy, 1969).
Il comportamento di un sistema, il suo utilizzo e sfruttamento, non possono esser slegati dalla realtà con cui sono interconnessi. I risultati sono prevedibili e si può affermare che il sistema terra non può essere compreso se viene considerato come una semplice somma delle parti che lo costituisce tralasciando le proprietà sistemiche che lo intereconnettono.
Lo Sviluppo Sostenibile
L’ integrazione delle discipline socio-economiche con quelle scientifiche, ha generato le basi della Teoria dello Sviluppo Sostenibile (E. Tiezzi 1999).
Grazie ad un solido background teorico questo approccio sistemico e multidisciplinare, consente la valutazione quantitativa della sostenibilità, dei processi produttivi e delle politiche di produzione e sfruttamento.
Attraverso l’analisi dell’utilizzo delle risorse, in relazione all’utilizzo dell’energia utilizzata e prodotta per la realizzazione di un processo, rende possibile calcolare la sostenibilità dello stesso e il suo impatto sul sistema. Utilizzando il “valore energetico” come unità di riferimento, è possibile includere nella valutazione il capitale naturale e quello umano, che in altri approcci rischia di essere escluso. L’integrazione di tali differenti approcci metodologici dimostra come sia possibile pervenire ad una valutazione ambientale che sia in grado di orientare le scelte di pianificazione e l’utilizzo delle risorse naturali (M. Ruth, 1993).
Il capitale naturale rappresenta oggi, il limite all’interno del quale modellare il nostro progresso. Le politiche di viluppo, non potranno più appellarsi esclusivamente, al carattere propulsivo delle tecnologie innovative e al carattere auto-equilibrante del mercato. Questa nuova visione, richiede lo sviluppo di modelli socioeconomici, con alla base
un approccio interdisciplinare che, consenta una pianificazione più precisa e attenta alle dinamiche del Sistema Terra e che orienti, il decisore politico, verso una visione integrata di aspetti economici, ecologici e sociali, allo scopo di realizzare una pianificazione sistemica e non meramente speculativa.
Questa forma mentis ha portato allo sviluppo di modelli socio-economici che presuppongono, l’affermazione di un rapporto stretto tra economia ed ecologia, che oggi si concretizza nella moderna teoria economica dell’Economia Ecologica(R. Costanza, 1997). La complessità delle metodologie e le difficili scelte che derivano da quest’approccio, sembrano però non indicare solo la via ad uno sviluppo sostenibile, ma anche la direzione verso cui dovremmo indirizzare, uno sviluppo tecnologico, che ci permetta di ricongiungerci con il sistema terra e tornate al passo con i suoi tempi.